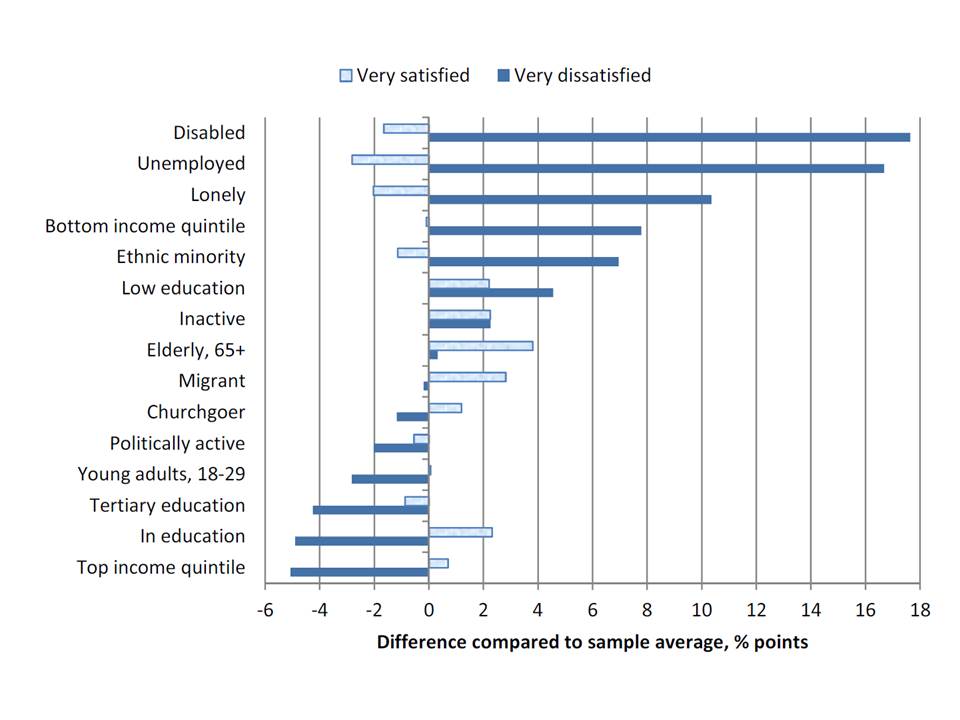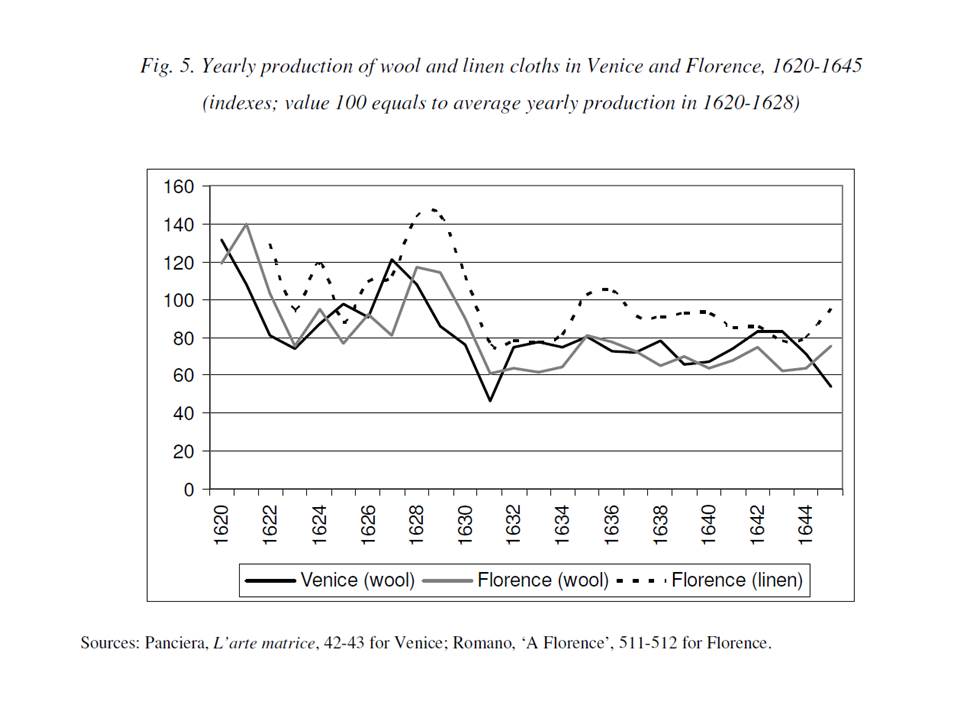Nel 1790 gli Stati di America non erano Uniti. Erano 13 stati. Ognuno con una sua autonomia fiscale, di cui era geloso. Attorno a loro un governo centrale, molto debole.
Questo preoccupava molto due grandi leader, visionari, americani: George Washington ed Alexander Hamilton. Che più di tutto sono preoccupati di 2 aspetti, legati tra loro.
Primo, è assolutamente fondamentale secondo loro convincere i mercati che gli stati americani, nuovi attori sui mercati finanziari, siano capaci di ripagare i debiti contratti. Il Nobel per l’economia Sargent, nel narrre magistralmente questa storia non raccontata sui libri di scuola americani, sa bene che ripagare i debiti è ovviamente costoso: distorce la tassazione verso il rimborso degli interessi piuttosto che verso la fornitura di beni pubblici. Come lo sanno i nostri due padri fondatori. Che ritengono tuttavia che i vantaggi di ripagare superino i costi. E’ probabile che tale convinzione derivi anche dall’incertissimo futuro della giovane democrazia americana di allora, sottoposta a potenziali nuove guerre di indipendenza e alla necessità di farvi fronte con risorse che devono venire da chi avrà la certezza di essere adeguatamente rimborsato.
Eppure le convinzioni di Washington e Hamilton, leader capaci, non dovettero risultare sufficienti a convincere i mercati: perché di fatto la Costituzione di allora, commenta Sargent, non dava poteri sufficienti al Governo centrale (il debito era dei singoli stati e non centralizzato, e così la decisione se ripagarlo o meno spettava a questi). Poteri che rimanevano nelle mani dei singoli Stati, tentati dal default, e non così consci dell’interesse nazionale in gioco, forse convinti che un loro default sarebbe stato in ultima analisi evitato dall’aiuto esterno di qualche altro Stato o del governo stesso.
C’era all’epoca, sostiene Sargent, una ambiguità fondamentale nelle politiche economiche, che metteva in grande difficoltà il funzionamento dell’economia americana – le cui famiglie, imprese, banche avevano come sempre bisogno di certezze sulle regole del gioco per investire nel futuro e così far crescere il Paese tutto. Washington ed Hamilton percepirono la necessità di rimuovere questa ambiguità “costituzionale” di fronte alla crisi fiscale e, rompendo gli indugi, decisero di mettere a punto una nuova, silenziosa, rivoluzione. Un colpo di stato, una circonvenzione delle regole ambigue, seppure scritte nella Costituzione di allora, che non davano poteri al Governo federale, lasciandolo in mano ai singoli Stati.
Una rivoluzione che aveva come singolo scopo quello di convincere i mercati che il debito sarebbe stato ripagato, credibilmente, e quindi da una sola entità. Il Governo federale. Per fare ciò, per far cedere il potere ai singoli Stati di emettere debito ci volle un quid pro quo. La garanzia che il Governo federale avrebbe lui ripagato il debito dei singoli Stati. Così facendo, otteneva anche il potere di espandere la propria capacità di tassare, levandola ai singoli Stati. Cosa non facile, nemmeno questa, ma una volta ottenuto il potere sul debito, non fu poi così difficile dice Sargent: i creditori degli stati divennero creditori del governo federale ed aiutarono Hamilton e Washington a modificare i poteri di tassazione a favore del Governo federale con una nuova legislazione. Hamilton e Washington crearono di fatto una lobby potente che si allineò ai loro interessi.
Cosa è una Costituzione secondo Sargent? “Chi sceglie cosa e quando”.
Ecco. Washington e Hamilton portarono a casa una nuova Costituzione. Per ottenere la certezza che quando un’altra occasione o emergenza si sarebbe presentata in cui ci fosse stato bisogno di emettere debito per finanziarsi, i mercati lo avrebbero fatto volentieri. Per esempio, nel 1803, quando Napoleone volle cedere la Louisiana per 50 milioni di dollari, cifra che non sarebbe stato possibile raggiungere senza l’accesso al mercato del credito.
Secondo Sargent la soluzione americana all’ambiguità che bloccava il Paese fu dunque quella di una modifica costituzionale nel modo in cui era governato lo stesso. Modifica che quasi non passò (la maggioranza delle persone forse non volevano questo passaggio di potere al Governo federale via dai singoli stati): Hamilton e Washington non seguirono le procedure previste per la modifica della Costituzione, un “grande dramma” una grande battaglia, che cambiò per sempre l’unione monetaria americana in unione politica, fino ai nostri giorni. Modifica che richiese un quid pro quo.
Rimossa l’ambiguità, con un colpo di stato illuminato e silenzioso, nacquero gli Stati finalmente Uniti d’America.
Ma fu proprio così? E l’Europa cosa può apprendere da tutto ciò?
(continua)