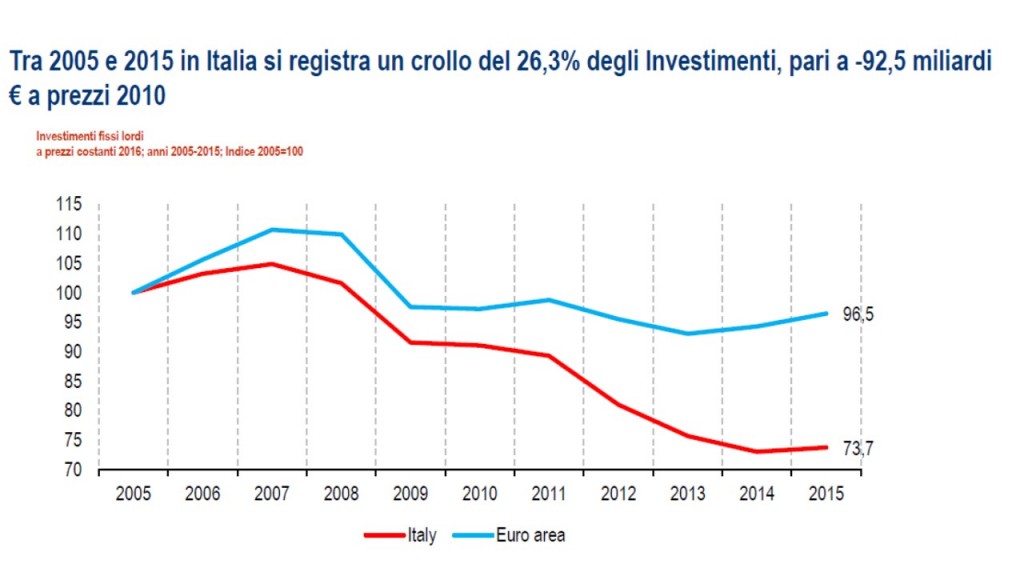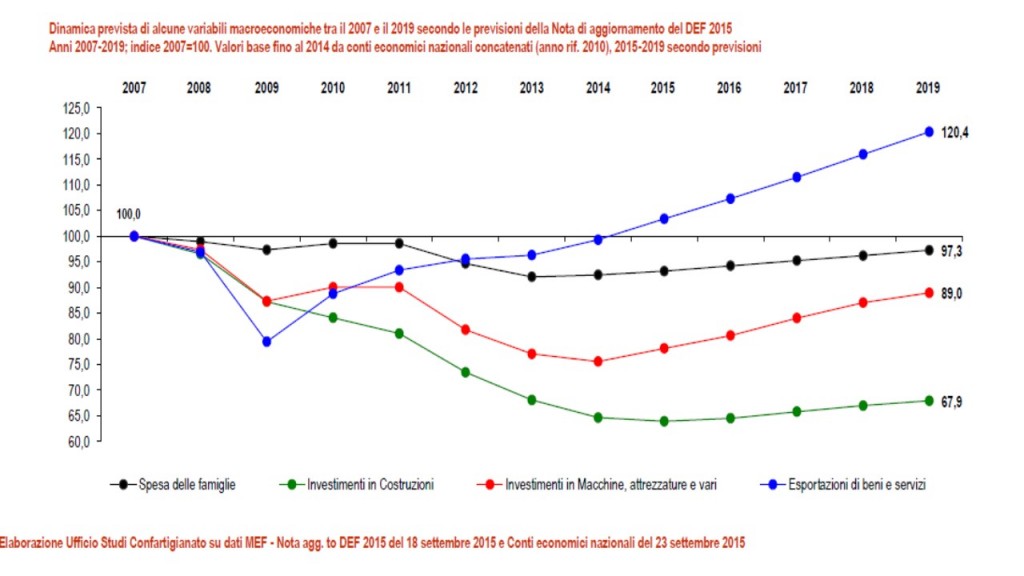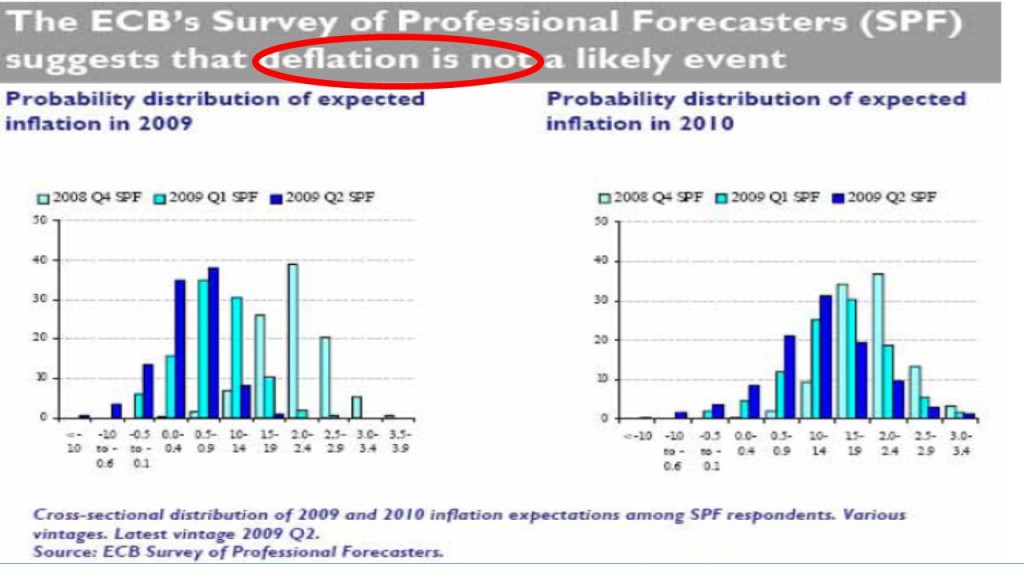59. 59 volte le parole ricerca o ricercatori. E’ questo il numero di volte che sono state utilizzate da alcuni ricercatori vincitori del prestigioso bando ERC nella lettera appello a cui ha fatto eco immediata la risposta del Presidente Renzi, pronto a raccogliere addirittura in due soli giorni la “sfida” a lui lanciata, con risorse e riforme a favore del rientro dei cervelli in Italia. Il Premier stesso ha utilizzato quelle due parole 16 volte. Un totale di 75 nelle due lettere.
http://bit.ly/1oghrMB
http://www.repubblica.it/scienze/2016/03/26/news/renzi_ricercatori-136316684/
*
Zero volte.
Zero è il numero di volte con cui sia i valenti ricercatori che il nostro Premier hanno menzionato la parola studente, studentessa o studenti.
Non è un caso. E’ il segno della totale indifferenza degli estensori delle due lettere al destino di questi ultimi. E pensare che la parola “universitates” stava anche a indicare quelle associazioni costituite dagli studenti a tutela dei propri diritti, come a Padova nella prima metà del Duecento.
In realtà, non volendo parlare di indifferenza, si potrebbe argomentare che altre sono le ragioni: che la ricerca è cosa separata dalla didattica e dall’insegnamento; oppure al contrario che parlare di ricerca è cosa equivalente a parlare di didattica (un buon ricercatore è un buon insegnante). Balle.
E’ che non interessa ai più, certamente non al nostro Premier. Più facile vincere la battaglia mediatica con qualche soldo per qualche ricercatore bravo che rimettendo l’Università nel suo complesso al centro del XXI secolo italiano, come lo fu nel Medio Evo nella nostra penisola, con atenei che nascevano come funghi, da quello che è oggi il Veneto sino alla Campania e più giù. Più facile mettere la patina esotica allo straniero che rientra dall’estero piuttosto che attribuire il merito a chi resta in trincea tutto sporco di fango e soprattutto più semplice che adottare una riforma coraggiosa e non più differibile?
I risultati di questa indifferenza agli studenti, una delle materie prime del nostro Paese, non sono attribuibili solo a quest’ultimo Governo, ma si toccano con mano: “per la prima volta negli oltre 150 anni di storia unitaria il numero degli studenti universitari si riduce. La quota di studenti universitari sul totale della popolazione, dall’unità d’Italia ad oggi aveva conosciuto un costante aumento: da meno dell’1 per mille fino all’età giolittiana e meno del 2 durante il fascismo, si passa a circa il 6 per mille all’inizio degli anni Sessanta, al 18 un ventennio dopo, fino a sfiorare il 30 nei primi anni del nuovo secolo. Rispetto al momento di massima dimensione (databile, a seconda delle variabili considerate, fra il 2004 e il 2008), al 2014-15 gli immatricolati si riducono di oltre 66 mila, passando da circa 326 mila a meno di 260 (-20%).” Fondazione RES, Rapporto 2015.
E questo mentre il nostro Governo si è impegno a raggiungere entro il 2020 il 40% di laureati nella fascia di popolazione tra i 30 ed i 35 anni. Oggi l’Italia, il Paese dove nacque l’Università, giace ultima nell’Unione europea, al 23%. Drammatico. Forse Renzi pensa che riuscirà a raddoppiare gli studenti con i 500 professori in un triennio che menziona nella sua lettera a Repubblica? Impossibile, a fronte dei crolli di quest’ultimo decennio, in cui i docenti da poco meno di 63 mila sono scesi a meno di 52 mila (-17%); il personale tecnico amministrativo da 72 mila a 59 mila (-18%); i corsi di studio scendono da 5634 a 4628 (-18%) e il fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) diminuisce, in termini reali, del 22,5% (dati Fondazione RES 2015)? Anzi ipocrisia pura, solo una facciata. Dietro la facciata, lo ribadisco, l’indifferenza più totale.
Se soltanto gli estensori delle due lettere a Repubblica dessero uno sguardo ai dati, scoprirebbero che l’Università italiana degli studenti sta diventando meno aristocratica ma per i motivi sbagliati: “alcune prime stime lasciano (…) pensare che il calo riguardi in particolare gli studenti provenienti dalle famiglie meno abbienti” (Banca d’Italia 2014, citata da Fondazione RES 2015) mentre i figli dei più abbienti sempre di più si dirigono all’estero, senza che entrino in Italia altrettanti studenti stranieri.
Le ragioni? E’ importante per rispondere comprendere innanzitutto che l’Università italiana non attrae i talenti presenti nelle fasce meno abbienti (secondo Cooper e Liu che scrivono sulla prestigiosa collana degli NBER papers, l’Italia ha un tasso molto alto di “undermatching” dove i ragazzi di maggiore talento decidono di non accedere all’Università) http://papers.nber.org/tmp/67657-w22010.pdf
e che, come menziona Avvisati dell’OCSE, “in Italia il tessuto industriale fatto di piccole e medie imprese appare più restio che altrove ad assorbire i laureati” (forse a ragione visto quanto scoprono i due ricercatori americani?). Fatto sta che il vantaggio relativo della laurea ai fini di un impiego si è assottigliato al punto da essersi rovesciato: il tasso di occupazione di chi ha fatto l’università è di un punto percentuale inferiore a chi ha solo il diploma (62% contro il 63%).
http://www.corriere.it/scuola/universita/15_novembre_25/ocse-italia-laureati-ultima-educaton-glance-universita-eac49a02-9357-11e5-a439-66ba94eb775e.shtml
E dunque? Qual è la radice del problema dell’Università italiana? Era proprio questa che ci aspettavamo di leggere nell’attacco della lettera del nostro Premier, che forse dovrebbe ascoltare, prima ancora dei 15 bravi ricercatori, la massa silenziosa di migliaia di studenti che disertano sempre più le nostre aule. Gli avrebbero spiegato, ma è un segreto di Pulcinella, che i mali si chiamano fuoricorso, fenomeno solo italico (“nei corsi triennali e a ciclo unico, nel 2011-12, era fuoricorso il 47% degli studenti al Sud, il 45% al Centro e il 35% al Nord; fra i laureati nel 2013 erano al quinto anno fuoricorso (in nettissimo ritardo), circa il 20% al Sud, poco meno al Centro, meno del 10% al Nord”- Fondazione RES) e abbandoni (ancora la Fondazione RES: “comparazioni internazionali riferite ad anni a cavallo dell’inizio del secolo, mostrano che la percentuale di abbandoni era in Italia la più alta in un vasto gruppo di paesi dell’Ocse; addirittura più della metà degli studenti non arrivava alla laurea, il doppio rispetto al Regno Unito e Germania. Dati recenti mostrano che una significativa quota di studenti abbandona i corsi universitari dopo il primo anno: il 12,6% al Nord, il 15,1% al Centro e il 17,5% al Sud (con una varianza molto elevata fra atenei e punte fino al 25%). A ciò si aggiunge che circa un terzo degli studenti del Centro-Sud, sempre al termine del primo anno hanno ottenuto meno di 15 crediti formativi (il 28% al Nord)”).
Come si fa ad avere più iscrizioni, meno abbandoni, meno fuori corso? Alcune soluzioni intelligenti e semplici le ha proposte un mio collega di Padova
http://www.corriere.it/scuola/universita/16_gennaio_20/vietato-rifiutare-voto-universita-ingegneria-padova-proposta-019afb60-bf4d-11e5-b186-10a49a435f1d.shtml
con il divieto di rifiutare il voto. Ma è evidente che abbiamo bisogno di più strutture, più amministrativi a supporto degli studenti, possibilmente che abbiano una conoscenza della lingua inglese se vogliamo attrarre studenti da tutto il mondo, docenti bravi al primo anno che non spaventino ma motivino i ragazzi.
Sarebbe a questo riguardo interessante sapere se i vincitori dei bandi internazionali di ricerca sarebbero disposti ad insegnare, come avviene negli Stati Uniti ai giovani bravi appena assunti, al primo anno, in classi con 200 studenti, seguendoli e motivandoli e venendo da questi giudicati ai fini della progressione della carriera. Certamente l’attuale politica tutta rivolta a premiare la ricerca scientifica ha generato l’opposto: i nostri bravi ricercatori (e Dio sa se ne abbiamo, tantissimi, la enorme maggioranza, e andrebbe detto a Rizzo e Stella che sembrano dimenticarlo, vista l’attenzione che riservano esclusivamente alle mele marce dell’Università) si rifiutano di farlo per dedicarsi alla ricerca e prediligono per questo l’insegnamento breve in aule piccole di anni avanzati o addirittura di Dottorati, senza capire che tanti giovani bravi che avrebbero potuto formare con qualità hanno abbandonato l’Università perché non li hanno conosciuti e non si sono potuti motivare a sufficienza per trovare le energie per proseguire gli studi.
Ma è ovvio che la vera risposta è poi nel cosa diamo a questi ragazzi. Nel XXI secolo globalizzato, dovremmo poter sperimentare corsi nuovi e valutarli alla luce dei risultati ottenuti e non bocciandoli a priori perché non rispettano le vetuste griglie ministeriali scritte da persone nate 60 anni fa e dovremmo stanziare risorse per quei corsi che attraggono studenti dall’estero perché l’università deve, assolutamente deve, insegnare ai nostri ragazzi a vivere nella diversità.
Per fare questo non bastano i 75 milioni di cui parla Renzi, o i 280 in un triennio, ci vogliono almeno dieci miliardi di euro e soprattutto ci vuole qualcosa che Renzi non ha nella sua testa perché non vi è interessato, un Progetto. Un Progetto che porti i meno abbienti a rinunciare a tre o cinque anni della loro vita lavorativa per formarsi in una Università del XXI secolo che dà strumenti, conoscenze, esperienza, confronto. Che insegna a dibattere, a lavorare in squadra, a negoziare.
Sarebbe una cosa di sinistra? Forse. Ma soprattutto sarebbe la cosa giusta.