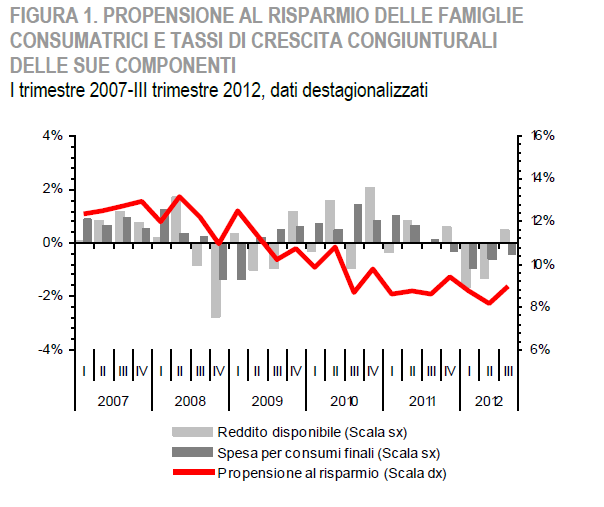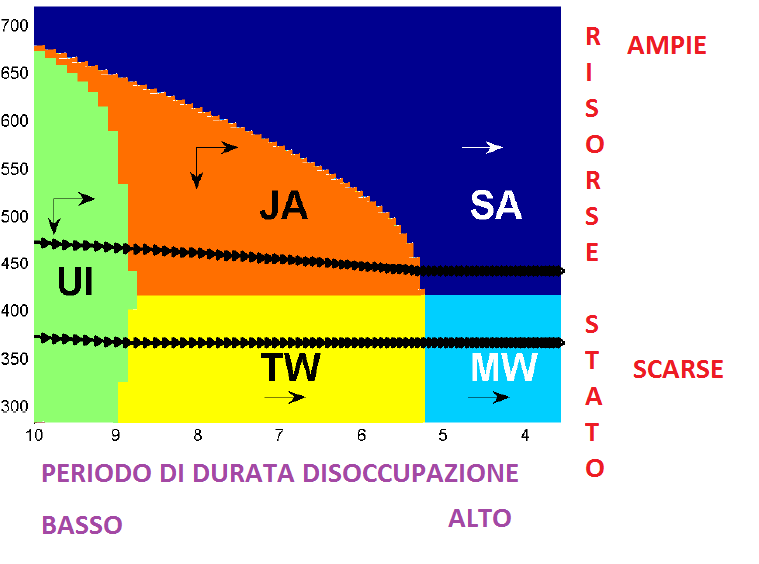Sono stato il primo studente di dottorato che ha avuto il Prof. Roberto Perotti quando arrivò ad insegnare alla Columbia University dopo avere lui stesso preso il dottorato al MIT di Boston. Dubbio onore per lui (lo feci impazzire ed ebbe santa pazienza a tollerarmi) grande onore per me. Mi fece le pulci su qualsiasi passaggio, su qualsiasi equazione, su qualsiasi affermazione. Un lavoro folle, ma che rese il successo finale con il titolo di dottore di ricerca la più bella medaglia al petto che posso ancora oggi appuntarmi, una spinta ad andare avanti con entusiasmo quasi infinito.
Dunque la mia stima per Roberto Perotti è, coerentemente, quasi infinita. Tra l’altro gli dobbiamo gratitudine per avere messo a soqquadro l’università italiani anni fa introducendo il Bollettino dei concorsi che tanti baroni di Economia ha terrorizzato, migliorando grandemente la qualità dei concorsi stessi. Proposte estreme, a volte sbagliate, le sue, ma importanti.
Quindi lo leggo sempre volentieri. Come oggi sul Sole. Dove dice: Per ridurre la pressione fiscale di cinque punti percentuali del Pil in cinque anni, e assumendo una crescita reale dell’1% annuo, bisogna ridurre la spesa di circa 70 miliardi ai prezzi attuali.
E che: L’alternativa cui ricorrono tutti sono i tagli ai consumi intermedi dello Stato e alle remunerazioni dei dipendenti. Ma non basta enunciarne la quantità, bisogna dire “come” attuarli. Per fare un solo esempio, si è parlato molto in queste ultime settimane della sanità. Ma in Gran Bretagna da quindici anni commissioni su commissioni studiano il problema di come ridurre la spesa sanitaria in un sistema pubblico, senza pregiudicare la qualità dei servizi, e non ne sono ancora venuti a capo. Quante persone in Italia hanno la competenza necessaria per fare una proposta organica e quantitativamente rilevante? Quanti partiti hanno fatto proposte concrete? …Che ci piaccia o no, il problema dei tagli alle tasse è prima di tutto, e molto semplicemente, un problema di ordine pubblico….
E conclude: Ma non c’è una lista o un commentatore (incluso il sottoscritto, per quel che conta) che sia in grado di proporre un programma dettagliato, credibile, e politicamente sostenibile per affrontarlo.
Ecco 4 punti su cui non concordo con Roberto:
a) presume che il fine ultimo dei tagli di spesa sia la riduzione delle tasse. Non è così. Ridurre le tasse oggi non aiuterebbe il ciclo economico (vedi post di ieri) e non affronterebbe il problema di lungo periodo numero uno del Paese: la urgente necessità di mettere mano alla ricostruzione delle infrastrutture materiali ed immateriali del Paese per vincere la battaglia della produttività del nostro settore privato con i nostri partner internazionali.
b) conclude che non ci siano persone in Italia capaci di tagliare le spese in acquisti di beni e servizi (non con tagli lineari) e anche di lavori. Non è vero. E’ vero che la Ragioneria Generale dello Stato è un moloch immobile dentro la quale ci si perderebbe anche Teseo con gomitolo annesso, ma questo è un (rilevantissimo) problema politico. Ma non tecnico. Su questo blog da 1 anno diciamo come si dovrebbe fare e sappiamo benissimo che si potrebbe fare. Il Regno Unito, al contrario di quel che dice Roberto, in questi 30 anni ha rivoluzionato la qualità dei suoi appalti pubblici con competenza e professionalità, premiate. Se lo sanno fare loro, lo sappiamo fare noi.
c) Ma parrebbe vero che nessun programma lo prevede. Appunto. E’ un problema politico. Ma nemmeno questo è vero. Il programma dei Viaggiatori in Movimento che stiamo ultimando in questi giorni (è dura! tanta fatica!) prevede un taglio del 3% di PIL di spesa nominale di acquisti di beni e servizi e lavori, senza toccare la spesa reale (ovvero: tagli di sprechi non tagli recessivi). Da usare però in modo ben diverso da quanto richiesto da Perotti: far diventare quegli sprechi spesa vera, per le infrastrutture a supporto del nostro settore privato. Università, scuola, dissesto idro-geologico, le nostre Pompei in malora, carceri, ospedali, tribunali, ICT. Così da ridare vita anche al settore privato, sia in termini di ciclo che di capacità di crescita strutturale.
d) Roberto Perotti a Gustavo Piga: “anche se superassi il vincolo politico, cosa impossibile, quella spesa ulteriore sarebbero ulteriori sprechi”. Vero, se governasse la macchina pubblica chi non ha mai preso un impegno nei confronti del taglio degli sprechi. Falso, se chi promette di tagliarli sa farlo e ha la forza politica per farlo.
E’ semplicemente ora di votare sulla base dei programmi. Ma non i temini di 25 pagine scritti in 3 giorni a 6 mani.
Quelli, per favore, no.