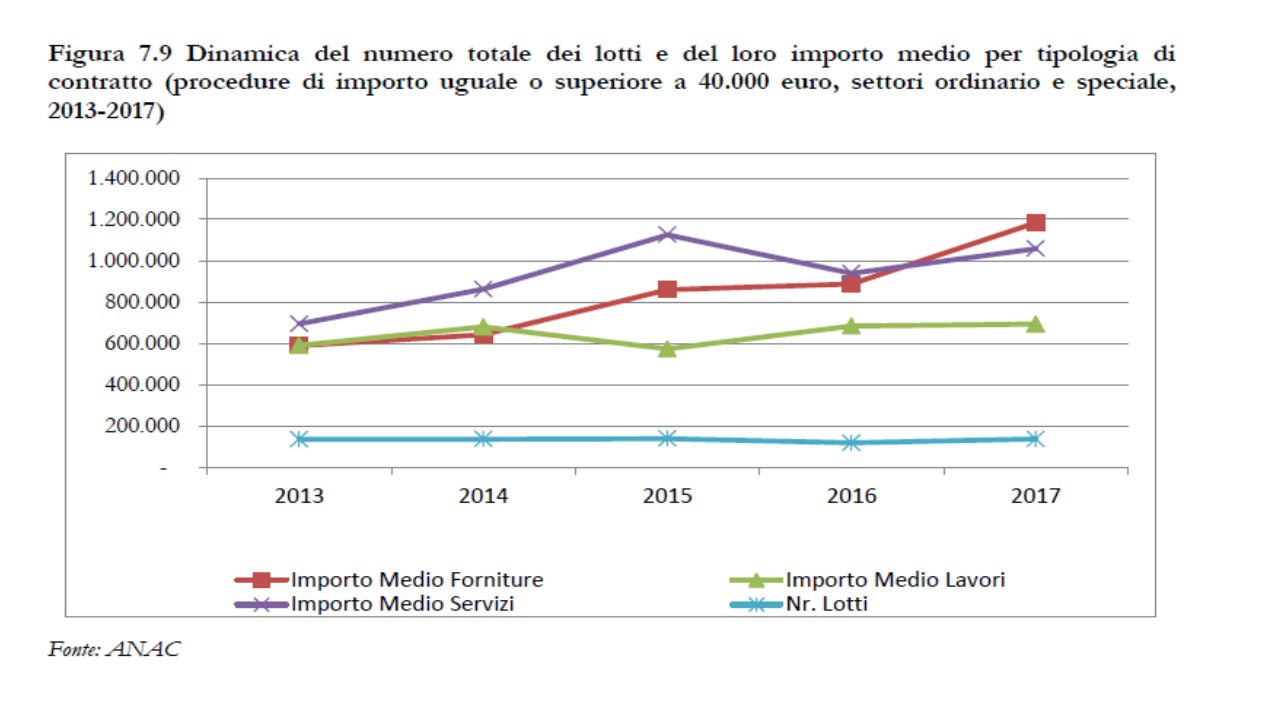Oggi sul Sole 24 Ore.
*
A distanza di ben 4 mesi dalla nascita del Governo il Paese sembra finalmente avere un quadro programmatico per il prossimo triennio. Un ritardo colpevole, che ha esposto il Paese alla crescita strutturale dello spread di 150 punti base a causa dell’incertezza sulle intenzioni della coalizione gialloverde. Ora quell’incertezza è stata rimossa, e non è poco: finalmente investitori ed imprenditori possono farsi un’idea del contesto in cui opereranno in Italia su di un orizzonte di medio periodo, condizione necessaria, anche se non sufficiente, per avviare progetti finanziari e reali utili al Paese.
Non sufficiente perché ovviamente è importante capire la portata ed il significato di quei numeri inseriti nel primo DEF gialloverde. Ora, mentre gran parte delle analisi a caldo si sono focalizzate sul rischio di un deficit su PIL 2019 al 2,4% invece che al 2%, va rimarcato come siano ben altre le novità dirompenti. In effetti, non è tanto una crescita del deficit di 0,4 punti percentuali di PIL in più, una mera goccia nel mare magnum della finanza pubblica di soli 7 miliardi di euro, che può francamente spaventare o rinfrancare mercati ed imprenditori sulle prospettive di stabilità e crescita del nostro Paese. No, la vera novità sta nella intenzione quasi rivoluzionaria del governo italiano di abbandonare il Fiscal Compact e l’obbligo a questo connesso di seguire nel tempo un trend rapidamente decrescente verso il bilancio in pareggio. Annotando sul DEF gialloverde un deficit pari al 2,4% del PIL non solo per il 2019 ma anche per gli altri anni del triennio, e comunque non convergente allo zero entro il quadriennio del DEF, si adotterebbe infatti una decisione di estrema rilevanza e non solo perché questa colloca l’Italia sostanzialmente al di fuori dall’architettura istituzionale europea (siamo in effetti il primo Paese membro firmatario del Fiscal Compact a farlo), dando uno scossone in vista delle prossime elezioni europee al dibattito politico. E’ altresì una decisione rilevante perché nella sostanza ci porrebbe di fronte ad un esperimento nuovo per l’area dell’euro, in cui la politica fiscale – dopo 7 anni di clausura – riacquisisce una sua autonomia. Fino ad oggi, la c.d. flessibilità annuale aveva infatti lasciato qualche spazio aggiuntivo di manovra, ma dato che essa sempre si accompagnava ad un parallelo annuncio di traiettoria recessiva di austerità per gli anni a venire, come le c.d. clausole di salvaguardia con l’aumento dell’IVA, per raggiungere il bilancio in pareggio, questa con una mano dava e con l’altra toglieva, vanificando i suoi intenti di stimolo dell’economia.
Da oggi, insomma, l’Italia può vivere in un nuovo paradigma di politica fiscale e la scommessa è che ciò possa avere un impatto esattamente opposto a quello dell’austerità dell’ultimo settennato, e cioè generare al contempo crescita economica e discesa del rapporto debito-PIL. Ma perché ciò avvenga è necessario che alla condizione necessaria di abbandonare il Fiscal Compact se ne affianchi un’altra, che abbia a che vedere con il tipo di utilizzo che verrà a farsi delle risorse addizionali così liberatesi. E qui dovremo ovviamente attendere gli esiti del dibattito parlamentare in tema di legge di bilancio, ma qualcosa è possibile già intuire dagli interventi dei leader dei due partiti della coalizione a valle della riunione del Consiglio dei Ministri.
Ma prima di tutto occorre chiedersi: quali utilizzi dei fondi derivanti dai maggiori deficit hanno più possibilità di generare crescita economica ed occupazione? Quelli che ovviamente sono capaci di stimolare sia, a breve, la domanda interna di beni e servizi, possibilmente quanto più legata a prodotti nazionali, che, a medio termine, l’offerta di prodotti competitivi da parte delle nostre aziende, in Italia ed all’estero. Un solo fattore di utilizzo delle risorse pubbliche ha la capacità di mobilitarsi in tal senso: gli investimenti pubblici, purché spesi bene. Le gare d’appalti pubblici, infatti, spesso finiscono per vedere la partecipazione di aziende nazionali, indirizzando la domanda interna della pubblica amministrazione verso beni prodotti da ditte italiane e quindi anche stimolando l’occupazione interna, ma anche, con le loro ricadute sul territorio, sostengono nel medio termine la produttività delle nostre imprese private, che beneficiano di beni pubblici (strade, infrastrutture materiali ed immateriali, edilizia scolastica ecc.) che rendono più competitivi i nostri fattori della produzione quando paragonati a quelli dei nostri rivali internazionali.
Tuttavia questo Governo, ritenendo di essere stato eletto con un mandato specifico, quello di lenire il dolore delle tante persone, specie quelle meno abbienti, più colpite dall’austerità degli ultimi anni, pare più interessato a usare i fondi per politiche redistributive a vantaggio di queste classi sociali più esposte. Sarebbe un duplice errore: primo perché gli investimenti pubblici anch’essi aiutano queste persone, ma con il vantaggio ulteriore di occuparle con un lavoro dignitoso e di generare un moltiplicatore di opportunità che reddito di cittadinanza, pensioni e flat tax non saprebbero avviare; secondo perché gli investimenti pubblici vengono incontro alle esigenze di una controparte politica di grandissima rilevanza, le future generazioni, che di quelle infrastrutture potranno beneficiare appieno.
Sarà dunque importante che nei mesi a venire si sfrutti l’enorme opportunità che questo Governo si è voluto meritoriamente creare abolendo de facto il Fiscal Compact per condurre in porto una manovra che redistribuisca non a parità di torta, ma da una torta più ampia, finendo anche per tranquillizzare i mercati e generando quella discesa del rapporto debito PIL che solo una maggiore e sostenuta crescita economica può realizzare. Il primo passo è stato fatto, non va sprecato.