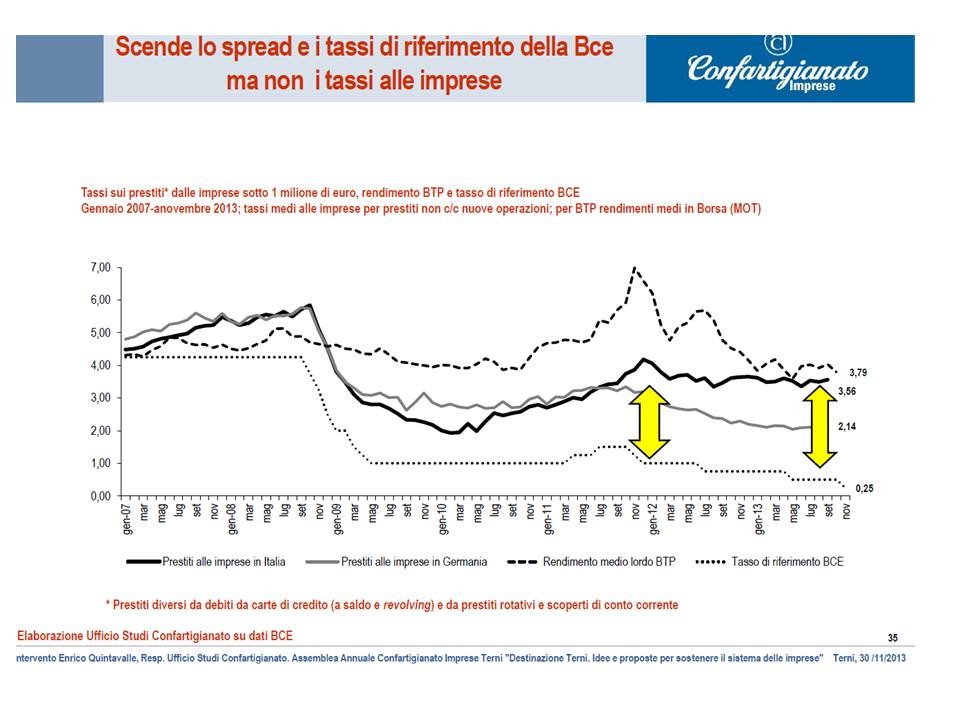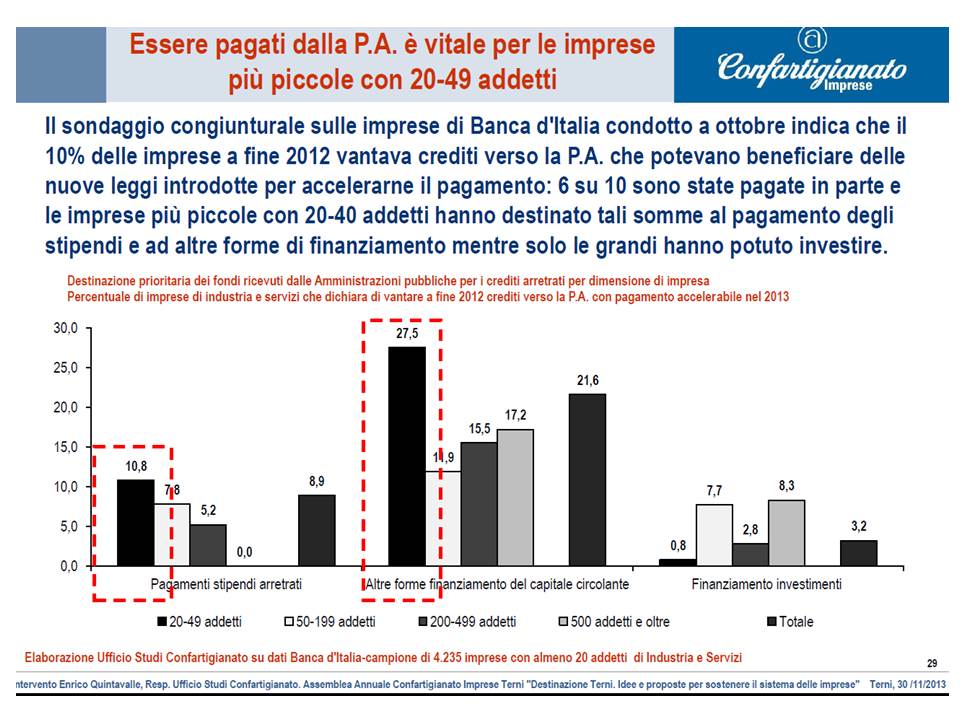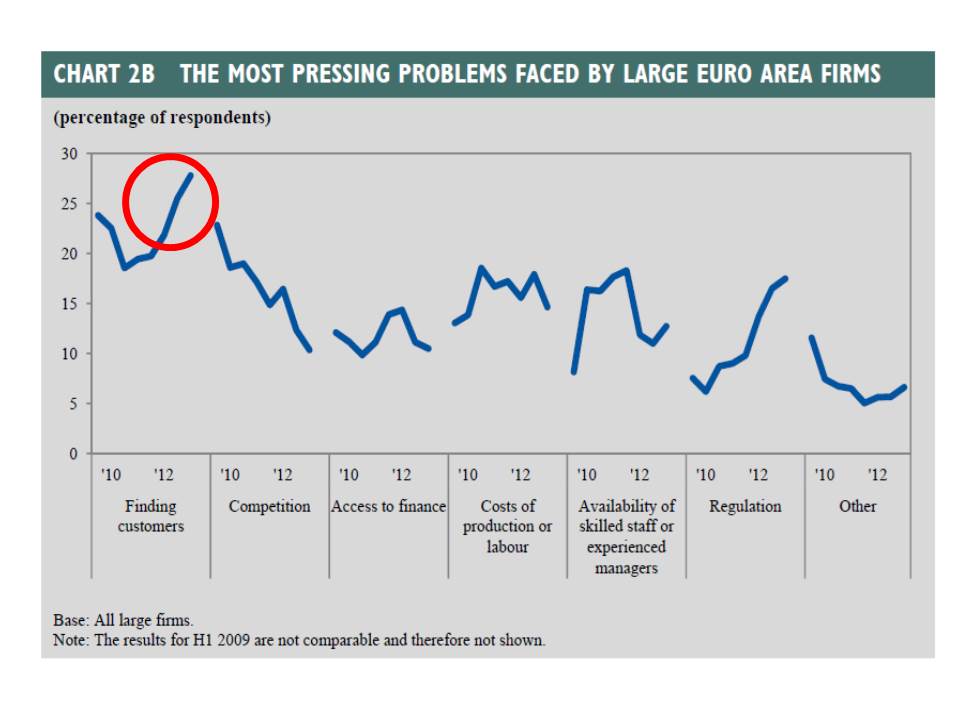Dice Squinzi, Presidente di Confindustria:
«A fianco della spending review abbiamo bisogno come il pane di una regulation review», ossia, di «rimuovere una inutile, costosa e opaca massa di regole che rischiano di rendere vano ogni sforzo di riduzione della spesa e di rilancio della crescita».
*
Sono felice di questa attenzione ai costi della regolazione da parte delle grandi imprese. Eppure. Eppure c’era un tempo in cui in Italia ci si schierava per parlare di abbattere i costi della regolazione per le piccole imprese, e solo per loro.
Una battaglia liberale, come quella dei Viaggiatori. Tanto liberale che era pienamente sottoscritta da Luigi Einaudi con queste belle parole:
«Migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. E’ la vocazione naturale che li spinge; non soltanto la sete di guadagno. Il gusto, l’orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, costituiscono una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno.»
Bella la piccola, bella. Così bella che come tutte le cose belle va protetta. Da «tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli». Con una politica liberale. Perché è illiberale tutto ciò che ostacola la libera scelta individuale che non danneggia altrui ma, anzi, lo avvantaggia. E’ dovere di una buona politica industriale, essere liberale, proteggere le piccole dalla regolazione costosa. Non le grandi, che da essa hanno tante armi per potersi difendere. Ma per la piccola in primis. Se poi a cascata ciò aiuta la grande, tanto meglio.
Ci fu un tempo, un tempo di titani in cui l’Italia aveva voglia di rinascimento, in cui un altro grande liberale del dopoguerra, malgrado fosse anche lui Presidente di Confindustria, non aveva dubbi nel sostenere che la battaglia della regolazione doveva essere a favore della piccola:
«Le piccole imprese hanno più di altre bisogno di appropriate facilitazioni legislative», diceva nel 1946 Angelo Costa.
Già, se solo l’avessimo ascoltato. Avremmo anticipato di 7 anni la rivoluzione liberale, non liberista, degli Stati Uniti che dichiaravano nel 1953 come “politica dichiarata del Congresso americano quella di … proteggere la piccola impresa statunitense“. Con la nascita dell’Agenzia indipendente, la Small Business Administration, riportante direttamente al Presidente degli Stati Uniti, volta a tutelare il bello che c’è nell’idea di generare impresa e dargli spazio vitale.
Politica, quella statunitense, mai abbandonata e rafforzata, nel 1980, col rifiuto di approvare qualsiasi regolazione che avesse un impatto economico negativo significativo su un numero sostanziale di piccole imprese. Perché “leggi e regolamentazioni disegnate per l’applicazione ad entità di grande dimensione sono state applicate uniformemente alle piccole imprese … anche se i problemi che hanno giustificato l’azione del governo possono anche non essere state causate dalle entità più piccole.”
Oggi in Italia siamo governati da piccoli leader che nemmeno si preoccupano se non danno corso, in mezzo alla rivolta della micro imprenditoria, a un disegno di legge, quello per la piccola impresa, che lo Statuto delle Imprese, approvato tra gli applausi ipocriti e bipartisan del Parlamento nel 2011, richiedeva si portasse alla discussione ogni 30 giugno. Monti e Passera tacquero nel 2012, Letta e Zanonato nel 2013, “scordandosi” di portare la legge al Parlamento. A fine 2012 l’Italia è secondo l’Europa al di sotto della media UE in ben sette politiche su 10 per le piccole imprese.
Per cambiare veramente, per introdurre quell’analisi dei costi della regolazione che un governo liberale degno di questo nome dovrebbe attuare, ci vuole competenza. Ci vuole, come chiedono i Viaggiatori, un Ministero della Piccola che levi le competenze al Ministero dello Sviluppo Economico che tutela solo le grandi. Che in questo Ministero lavorino raffinati economisti, statistici, giuristi che facciano bene il loro lavoro di valutazione, assieme e col sostegno delle Associazioni delle Piccole Imprese, come negli Stati Uniti.
Ma per avere queste competenze ci vogliono soldi, altro che i tagli stupidi del Governo Letta sulla spesa per stipendi pubblici.
Ma per avere quei soldi per remunerare le competenze dove li troviamo?
Che domande, in una intelligente spending review, che trovi le finanze per spendere meglio tagliando là dove spendiamo peggio, negli appalti pubblici così preziosi per il Paese ma con così tanto grasso da scartare.
Perché questa è la vera spending review: non i tagli, ma dove si vuole spendere, bene, e dove si trovano i soldi per spendere bene.
Quindi caro Presidente Squinzi, le direi, no, non a fianco, la regulation review. Va fatta all’interno della spending review: perché per farla bene ci vogliono soldi e per trovare i soldi ci vogliono i risparmi.
Tutto si tiene. Questo Stato uccide il Paese e senza un grande Stato non si rilancia il Paese. E questa generazione di politici è incapace di combattere per questo nuovo Paese a portata di mano.