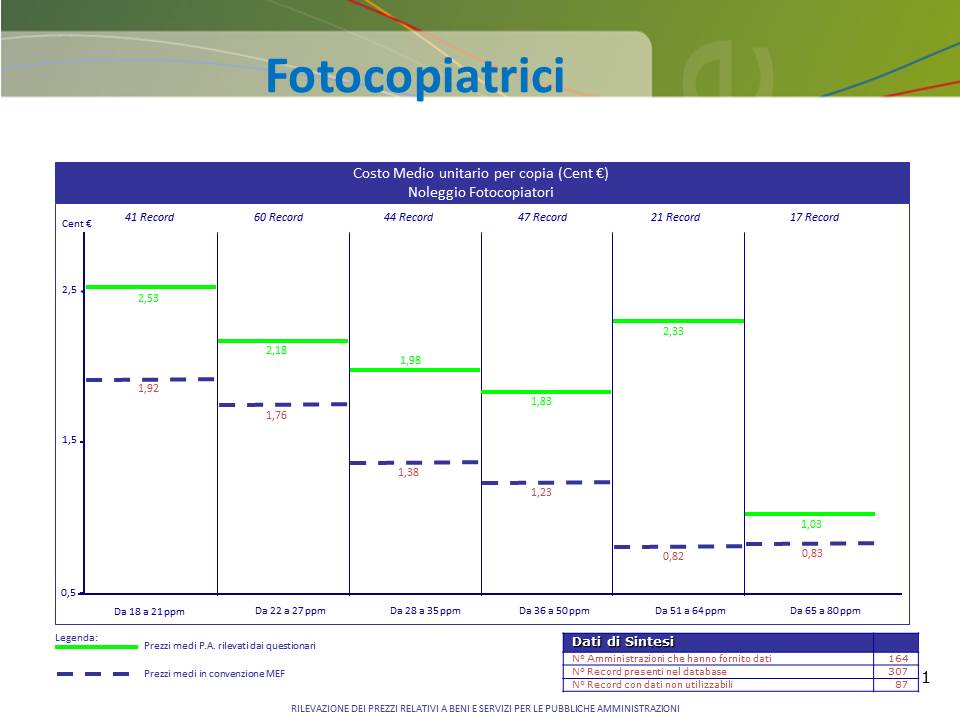Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Ill. mo On. Enrico Letta
e p.c. Al Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali
Ill. mo Prof. Enrico Giovannini
Ill. mo Presidente,
in data 7 febbraio 2012, preoccupato dell’attuale gravissima situazione in cui versano tantissimi giovani italiani alla luce delle difficili condizioni economiche, ho deciso di avviare sul mio blog una petizione per la raccolta di firme volta a richiedere l’avvio di un progetto di assunzioni a tempo determinato nelle strutture pubbliche di quei tanti giovani che rischiano, in assenza di migliore alternativa, di ingrossare la crescente schiera di quelli che l’Istat definisce “scoraggiati”. Prendendo spunto dall’esperienza così fondamentale per tanti di noi del servizio militare, che unì un Paese altrimenti diviso da cultura e disponibilità economiche, e dall’attuale crisi in cui versa il servizio civile, l’appello richiede il lancio di un progetto di nuovo Rinascimento dove a fronte di un costo moderato potremo ridare bellezza e concretezza all’azione del pubblico nel Paese, generando aumenti di produttività utili a tutti gli attori rilevanti: cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche.
Le allego il testo dell’appello.
Esso è stato rapidamente sottoscritto da più di mille e cento cittadini, alcuni dei quali colleghi universitari ma anche, e soprattutto, giovani che – occupati o meno – hanno visto in questa proposta una iniziativa volta a restituire speranza alle nuove generazioni attribuendogli una “responsabilità del fare” che sentono di assumersi in prima persona. Mi pregio di allegarle anche le firme di tutti i sottoscrittori dell’appello.
Questa medesima lettera è stata inviata al Presidente Mario Monti, e per conoscenza al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in data 18 aprile 2012. Le allego anche il testo della risposta ricevuta il 20 giugno 2012 da parte del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consigliere Dott. Manlio Strano, nella quale si mostrava vivo apprezzamento per il progetto.
Nell’anno trascorso la disoccupazione giovanile è cresciuta del 6%. Politiche che abbassino il costo delle assunzioni per i giovani, in questo clima di scarsità di domanda, sono destinati a fallire perché le aziende non intendono scommettere sul futuro. C’è bisogno di un intervento diretto pubblico.
Io sono certo che lei avrà modo di valutare questa richiesta in tutti i suoi aspetti e le darà il peso che merita, ancor più del vivo apprezzamento già ricevuto dal suo predecessore. Credo fermamente che abbiamo, tutti noi adulti che siamo stati aiutati dalla forza e dalla passione civile dei nostri nonni e genitori, il dovere di restituire ai nostri figli e nipoti almeno in parte e con generosità quanto ricevuto.
Suo,
Gustavo Piga
Chiediamo al Governo che destini 1% del Prodotto Interno Lordo di ogni anno finanziario del prossimo triennio, 16 miliardi di euro, senza addizionali manovre fiscali – come permesso dal Patto fiscale di recente approvazione dato lo stato di recessione della nostra economia – ad un Piano per il Rinascimento delle Infrastrutture Italiane che veda occupati ogni anno 1.000.000 di giovani ad uno stipendio di 1000 euro mensili, con contratto non rinnovabile di 2 anni, al servizio del nostro Patrimonio artistico, ambientale, culturale e a quelle iniziative della Pubblica Amministrazione che siano volte a rafforzare il nostro sistema produttivo nazionale riducendo barriere e ostacoli che si frappongono allo sviluppo di idee, progetti e, domani, di imprenditorialità.