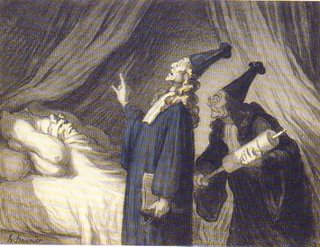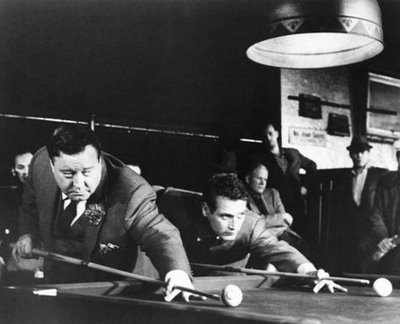Il governo crede che oggi l’Europa fronteggi una domanda fondamentale a cui rispondere: che valore (l’Europa) ha aggiunto e potrà aggiungere in futuro, oltre quello derivante dall’azione nazionale o locale, nel promuovere la prosperità e la sicurezza dell’Europa, e nell’aumentare l’influenza della voce dell’Europa nel mondo?
Ecco questa domanda (chi l’ha posta ve lo dico tra poco), pur se imperfetta nella sua struttura ortografica, avrei voluto fosse stato un qualsiasi Governo italiano a porsela. Ma la crisi ci porta lontano dal porci le domande giuste, aggravando di conseguenza la crisi.
Continuiamo a proporre soluzioni tecniche per attenuare la crisi di domani mattina dello spread senza sapere indicare la strada da seguire per ottenere il risultato che vogliamo raggiungere tra 100 anni. Roberto Perotti sul Sole 24 ore ha mirabilmente illustrato i difetti dell’ennesima proposta, quella della garanzia dei depositi bancari:
Se anche, per assurdo, non ci fosse alcun problema con il debito pubblico greco, finché c’è un rischio di un’uscita dall’Eurozona i cittadini greci continuerebbero dunque a portare i propri depositi in Germania … In questa situazione, un’assicurazione europea scongiurerebbe una fuga dalle banche greche solo a due condizioni: i depositi dovrebbero essere garantiti per il loro valore in euro, ed anche se la Grecia dovesse abbandonare l’euro. Ciò è impossibile: è impensabile che i contribuenti dell’Eurozona siano chiamati a garantire i depositi di un Paese che ha abbandonato l’euro, e per di più a garantirne il valore in euro.
Ma c’è di più. Se anche questa garanzia venisse data, essa, perversamente, aumenterebbe la probabilità che la Grecia abbandoni l’euro! Come abbiamo visto, un’uscita dall’Eurozona con la conseguente svalutazione della dracma ha il vantaggio di rendere l’economia greca più competitiva; ma ha il grave costo di diminuire il valore di tutta la ricchezza (inclusi i depositi) che viene ridenominata in una dracma svalutata. Un’assicurazione europea che garantisca il valore dei depositi in euro eliminerebbe gran parte del costo dell’uscita dall’Eurozona, lasciando solo il vantaggio della svalutazione. L’incentivo ad abbandonare l’euro per i politici e i cittadini greci aumenterebbe, e questo grazie a un’assicurazione pensata per scongiurare proprio questo evento!
È qui la differenza con l’assicurazione federale sui depositi Usa. Negli Stati Uniti, se c’è una crisi bancaria in Texas, nessuno in quello Stato penserebbe di abbandonare il dollaro. Nell’Eurozona questo rischio c’è. È una piccola differenza, ma con enormi conseguenze.
Domanda chiave a Roberto: e perché con una crisi bancaria in Texas, a nessun texano verrebbe in mente di abbandonare il dollaro? Ovviamente non perché non vi sarebbero guadagni dallo svalutare, così come per la Grecia. No. Semplicemente perché ci si sente parte di un progetto più ampio, da cui ci guadagna, ieri oggi e domani, lo Stato più povero, con i trasferimenti dagli Stati più ricchi, ma anche gli Stati più ricchi, dato che grazie alle dimensioni e forza dell’Unione influenzano lo scacchiere geopolitico a loro favore, economicamente e culturalmente parlando.
Non se ne esce: l’unione bancaria e tutte le altre belle o meno belle proposte tecniche sono figlie dell’unione culturale e sociale, e non viceversa. Vero è che gli economisti leggono poco i libri di Storia, ma questo è, francamente, così ovvio…
E dunque torno alla prima frase, pronunciata non da un governo dell’euro, ma dal governo di sua Maestà la Regina,il Regno Unito, che, a distanza di 39 anni dal suo ingresso nell’Unione europea ha lanciato una nuova iniziativa pluriennale di formidabile ambizione come sintetizzato dal Ministro degli esteri britannico:
“Oggi, ho pubblicato una ordinanza (Command Paper) che descrive nel dettaglio come affronteremo … “l’esame dello stato attuale delle competenze dell’Unione europea (UE). Tale esame sara un audit di quello che fa la UE e di come ciò impatta sul Regno Unito. Esaminerà dove si concentrano le “competenze”, siano esse esclusive dell’UE, condivise o a supporto, di come queste siano utilizzate e di cosa ciò significhi per il nostro interesse nazionale.” E questo perché “l’Unione europea fronteggia 3 sfide urgenti: la globalizzazione, la crisi dell’eurozona e la legittimità democratica”.
Ce lo dicono, lo dobbiamo sentire da quei britannici che pian pianino stiamo perdendo (anche se loro lo negano con un fare minimalista adorabile) come àncora preziosa del nostro futuro progetto geopolitico, proprio per la nostra incapacità di progettare un futuro a 100 anni (e seguono ricchi dibattiti alla London School of Economics per preparare l’intellighenzia).
Non c’è tanto tempo per lasciare un futuro europeo ai nostri figli. Anche perché tra poco non ne vedranno l’utilità. Pochi giorni fa Alessandro Piperno ci ricordava, in un interessante articolo sul Corriere, come “è ogni istante più vicino il giorno in cui l’ultimo sopravvissuto della Shoah scomparirà dalla faccia della Terra…. Con la scomparsa dalla faccia della Terra dell’ultimo internato, infatti, non ci sarà più nessun essere umano capace di testimoniare con il proprio corpo, con il proprio spirito, con il proprio cervello, con il proprio sangue quello che successe in Europa centrale più di mezzo secolo fa. Da quel momento in poi i testimoni verranno sostituiti dai figli e dai nipoti…. Tutto questo autorizza l’ipotesi che, nel corso di poche generazioni, la Shoah — inghiottita dai decenni trascorsi, divorata dalla retorica istituzionale, banalizzata dal profluvio bibliografico, oltraggiata dal risentimento dei negazionisti, offuscata da qualche altra tragedia più incombente — diventi un fantasma? Ovvero, qualcosa di non immediatamente intellegibile. Qualcosa imposto dall’alto: come una religione, o come una vecchia carta costituzionale. Una ricorrenza in mezzo a tante altre ricorrenze. Quanto tempo deve passare prima che il più spaventoso dei ricordi cada in prescrizione?”
Ecco, anche altre cose si possono dimenticare. Quanto tempo ci vorrà perché i nostri giovani, cresciuti all’ombra gentile della pace, non capiscano più dell’importanza di lottare per una Grecia sorella della Germania? E quanto stiamo noi accorciando questo tempo con le nostre miopi ed erronee politiche? Quanto tempo prima che i giovani italiani non comincino a parlare della Germania esattamente come parleranno dell’Italia i giovani tedeschi, con sprezzo e indifferenza come hanno fatto per secoli, interrotti soli dalla costruzione dell’Unione dal dopoguerra?
Come spiegargli, in assenza delle giuste politiche, che, ad un tavolo negoziale con Cina e Stati Uniti, l’Europa porterebbe con la sua storia e la sua filosofia il più importante bene planetario di tutti, quello della solidarietà?
E quanto tempo abbiamo per non diventare un minuscolo e banale frammento di questo incredibile video (cliccate qui per vederlo, grazie Lucio Picci)? Quanto? Quanto?