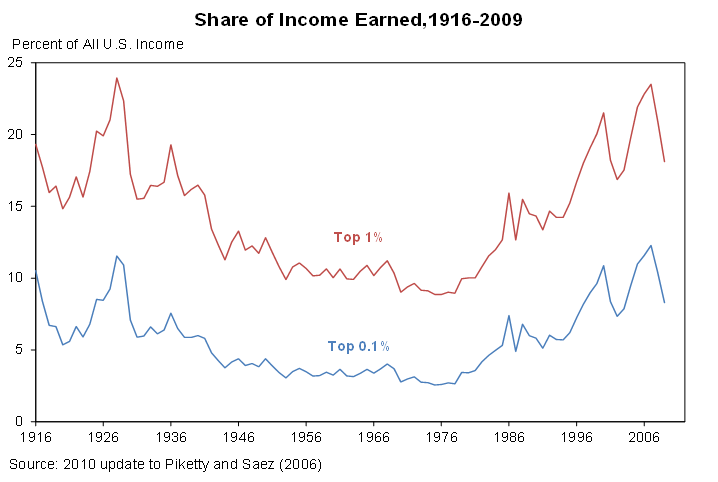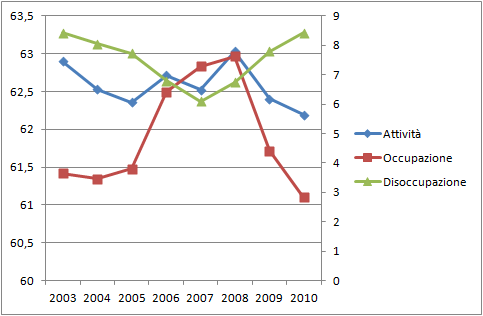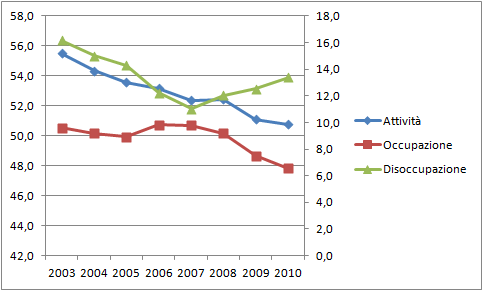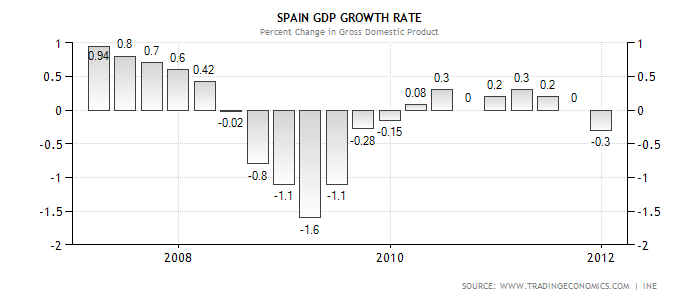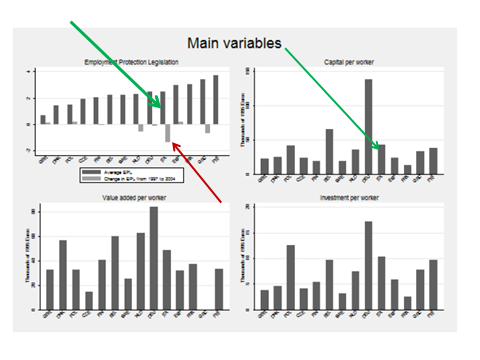Non avevo terminato su quanto asserito dai miei colleghi Fabiani e Giavazzi sul Corriere, che si ritrovano dalla stessa parte della barricata quando chiedono anzi “sperano” che le università telematiche non vengano accreditate. E’ uno strano modo di vedere le cose per un liberale (lontano cioè dalla visione di Einaudi che diceva sul tema: “intendo indagare quale ordinamento rispetti meglio il principio di libertà”). Se ci sono progetti che superano un livello minimo di qualità, perché non approvarli, ed anzi perché non approvarli e basta, lasciandogli alcuni anni di tempo per verificare se hanno stabilito corsi di una certa qualità? Ci sono così tanti corsi di laurea nelle università normali (non telematiche) che probabilmente meriterebbero di essere “ispezionati” e “chiusi”, che abbiano pochi o tanti studenti che sia: perché non cominciamo da lì i divieti?
Perché sarebbe comunque poco intelligente. Prima di tutto, chiariamo subito che la questione va ben al di là del se dire sì o no alle “telematiche”. Anche perché abbiamo bisogno di molte e molte università per recuperare il nostro gap di laureati rispetto al resto dell’Europa. E abbiamo bisogno di università tecniche dove formare futuri lavoratori, in sintonia con le organizzazioni imprenditoriali, private o pubbliche che siano. Capirete dunque che assieme all’aumento del numero di università si pone urgentemente la questione delle “licenze” alle università per operare, come per i commercianti. Decisione da prendere in maniera meditata. Perché una decisione sbagliata su di ciò potrebbe divenire ostacolo alla crescita del nostro numero di laureati (come la situazione odierna, avendo noi in Italia un bel cartello di una qualche settantina di atenei). Come comportarsi?
Vietare di operare in caso di “scarsa qualità”? E’ veramente opera complessa. Sulla base di quali criteri? Mi vengono in mente i film americani dove si deve selezionare la giuria per giudicare l’accusato e gli avvocati si danno da fare per escludere giurati che paiono partire già prevenuti. Ecco non lascerei mai a Giavazzi e Fabiani in una commissione a valutare le università telematiche: hanno già un’opinione a prescindere.
Ma anche un giudice “obiettivo”, a quale università dovrebbe dare il suo OK? C’è chi dice, lasciamole entrare tutte che poi le famiglie “votano” con i piedi, spostandosi verso le migliori. Non è esattamente così. Sia perché esiste il valore legale del titolo di laurea che riduce il valore di studiare nelle università migliori (e non le segnala al pubblico) sia perché, come dicevano tempo fa sul blog noise from amerika, “una frazione della domanda è principalmente interessata ad una formazione accademica vicino a casa; un’altra frazione della domanda non è proprio in grado di valutare la qualità della formazione né mai lo sarà; una ulteriore frazione della domanda teme la qualità del servizio didattico, invece che desiderarlo. … Propongo quindi di capire meglio quali siano le effettive caratteristiche della domanda. Se però la domanda non reagisse come immaginato, verrebbero a cadere le indicazioni di policy.”
OK, allora aboliamo pure il valore legale della laurea là dove possibile. Fatto ciò o non fatto ciò, resta però la questione chiave di come identificare la qualità (altra questione, diversa ma legata, è quella di come “incentivare” la qualità, ma ne parliamo solo un poco alla fine di questo post) per aiutare coloro che vorrebbero inviare il loro figlio ad una buona università.
Qualcuno dice: facciamo fare al Ministero (o all’Agenzia Anvur) il pagellino alle università e pubblichiamolo, così renderemo note le classifiche alle famiglie che si orienteranno meglio. E’ un’idea. Ma vi immaginate voi le pressioni politiche su quei poveri burocrati?
Una soluzione, menzionata nella bella intervista da Daniele Bertolini, è quella di delegare la valutazione della qualità a organi indipendenti a cui si rivolge la singola università (tipo agenzie di rating regolate) per essere sia accreditata con un livello minimo sia valutata nel tempo, per salire (o scendere) nella valutazione dopo essere stata accreditata.
Soluzione, direte voi, che soffre del problema di come identificare le buone università. Bertolini menziona come “la molteplicità dei criteri consentirebbe di formare innumerevoli classifiche a seconda del peso relativo da dare a ciascun elemento. Dietro ogni classifica c’è sempre una scelta circa l’importanza da dare ai vari elementi presi in considerazione. In questo modo, ciascuno sarebbe libero di scegliere a quale ranking affidarsi o quale sia l’ente valutatore più prestigioso o più affidabile”. Vero, ma le famiglie hanno bisogno di messaggi chiari, non confusi. La prima cosa più importante che mi viene in mente: come è noto molto spesso i professori bravi nella ricerca insegnano poco agli studenti agli studenti delle lauree triennali (quelle che si affrontano usciti da scuola, per capirci) e molto spesso professori bravi nella didattica, capaci di trasmettere tanta conoscenza, non sono necessariamente i migliori ricercatori. Come catturare questo aspetto?
Negli Stati Uniti la questione è stata risolta creando di fatto due canali universitari: uno per la didattica (tantissimi piccoli college dove importante più di tutti è la didattica) ed uno per la ricerca (alcuni college di grande reputazione dove conta molto la qualità della ricerca). Con il vantaggio aggiuntivo di concentrare presso pochi atenei di qualità i migliori nostri ricercatori, oggi dispersi presso tanti atenei diversi, con possibilità di interagire meglio tra loro.
C’è un vantaggio in un sistema a prevalenza pubblico come quello italiano di lavorare verso un sistema di questo tipo. A queste università, qualora pubbliche, potrebbero essere associati schemi di finanziamento diversi. Più soldi alle università di ricerca per meglio remunerare i suoi docenti/ricercatori, meno soldi a quelle più di didattica, ma sempre legati alla loro qualità.
Insomma, con o senza valore legale del titolo di laurea, un mondo ideale sarebbe costituito (forse) da tre fasce di università: fascia A, di università che conferiscono solo la laurea triennale e master specialistici (specie tecnici, ma non solo); fascia B che conferiscono lauree biennali e master specialistici e fascia C di atenei di ricerca con programmi avanzati e dottorati. Si potrebbero prevedere 15 atenei di qualità, 5 al Nord, 5 al centro e 5 al Sud. Ogni 5 anni il migliore ateneo di fascia B in ogni area geografica si candida, se lo desidera, per sostituire il peggiore ateneo di fascia C di quell’area, così da non far diventare un “cartello impigrito” il gruppo di top 5.
Ogni università di fascia A e B viene accreditata per i (diversi) requisiti minimi (possibilmente non troppo stringenti) e ottiene un rating da una serie di certificatori che si cercherà essa stessa tra quelli autorizzati.
Altro che valore legale o meno del titolo di studi, qui c’è da rialzare la posta in gioco. C’è in ballo il chiudere una volta per tutte il nostro gap strutturale di laureati e incentivare la qualità della ricerca in maniera credibile. E il tutto, in un colpo solo.
 Interessante giornata in Danimarca parlando con gestori di fondi pensione. La Danimarca pare schierata con la Germania, malgrado mantenga la sua valuta, sul modello rigorista.
Interessante giornata in Danimarca parlando con gestori di fondi pensione. La Danimarca pare schierata con la Germania, malgrado mantenga la sua valuta, sul modello rigorista.