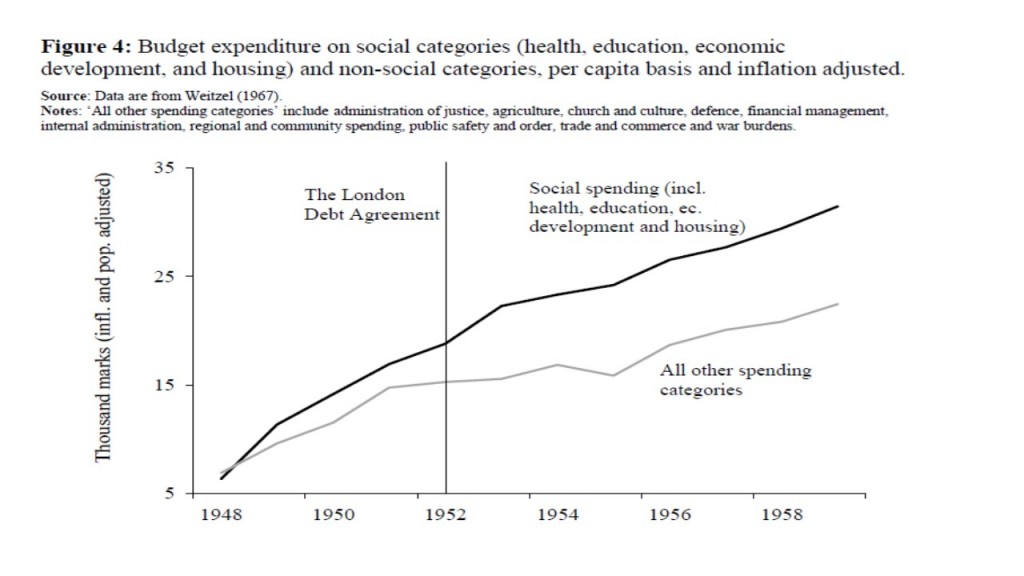“L’Europa di Maastricht, pur con tutte le sue contraddizioni e esitazioni, è stata pensata dai suoi ideatori e realizzatori come un’alternativa alla globalizzazione selvaggia, che si predica e si pratica da oltre Atlantico, così come la predicò e la praticò l’Inghilterra dal 1820 al 1890. […] Un edificio, anche se non esteticamente eccelso […] eretto per difendere la ragionevolezza del sistema socio-politico europeo. […] Di unità monetaria, infatti, c’è assoluto bisogno perché non inizi e progredisca a velocità crescente l’opera di demolizione dell’unione doganale ed economica raggiunta in Europa con quarant’anni di sforzi”.
Marcello De Cecco, L’oro d’Europa, Donzelli, Roma 1999, p. 27.
Citazione estratta da “Marcello De Cecco 1939 – 2016” di Paolo Paesani.
*
Questo blog ha sempre difeso l’importanza dell’euro come collante per i paesi dell’Unione europea per procedere verso quegli Stati Uniti Europei che, se e quando si affermeranno, ci permetteranno di partecipare al tavolo delle decisioni globali con i nostri valori, unici, e non essere sul menù, come avverrebbe in caso contrario.
“Se e quando”. Sul “se” ho avuto modo di esprimere in questi 5 anni su questo blog una crescente disillusione al riguardo, a causa delle scellerate politiche di austerità che, in una crisi così grave e asimmetrica come questa, che colpisce violentemente alcuni stati membri e non altri, rappresentano l’opposto di quanto andrebbe fatto, con un esercizio di solidarietà verso quei paesi che soffrono maggiormente.
L’austerità e non l’euro come colpevole. L’euro è un collante, ho detto. Niente di più, niente di meno. Si può mettere tutta la colla che volete ma se la superfice non è porosa, non attacca nulla. Quando però trova la superficie adatta incolla benissimo. Date all’euro la fine dell’austerità e vedrete che la colla funzionerà. Lasciatelo preda dell’austerità e contate i giorni per le fine del progetto di unione. Su questo tornerò alla fine del post.
Poi c’è il “quando”. E’ un po’ di tempo che non scrivo sul quando si affermeranno gli Stati Uniti Europei. Vi torno, sollecitato dalla scoperta di uno stimolante saggio di Hugh Rockoff della Rutgers University intitolato “How Long Did it Take the United States to Become an Optimal Currency Area?”, ovvero “Quanto ci hanno messo gli Stati Uniti a divenire una Area Valutaria Ottimale”?
http://www.nber.org/papers/h0124
Che si pone una domanda chiave: guardando alla storia degli Stati Uniti dalla loro nascita politica – fine del XVIII secolo – a quanto ammontano i costi che gli stati degli Stati Uniti hanno dovuto sopportare per aver adottato una moneta ed una politica monetaria comune?
E la risposta è chiarissima: costi decisamente significativi. Tanto da far dubitare della convenienza economica di questa scelta.
*
Una premessa. Prima della Rivoluzione ogni colonia degli Stati Uniti aveva valute diverse: la sterlina inglese e il peso spagnolo erano accettati pressoché ovunque, ma le singole colonie cercarono di stampare anche la loro moneta legale per sostenere le loro entrate fiscali o a supporto dei debitori locali. Con la promulgazione della Costituzione si proibì ai singoli stati di emettere valuta e venne dato al Congresso il diritto esclusivo di coniare moneta, stabilendo di fatto una unione monetaria tra i diversi stati.
Perché si decise in questa direzione? L’esperienza dei primi anni dopo la Rivoluzione mostrava come l’esistenza di autonomia monetaria dei singoli stati avrebbe messo a repentaglio la stabilità politica (da ora in poi mie le traduzioni dall’inglese): “la rapida deflazione dopo la Rivoluzione aveva lasciato i contadini con debiti pesanti. In quegli stati in cui predominava l’agricoltura, crebbero con insistenza le domande per moratorie sui debiti e sulle imposte. Gli Stati cercarono di fronteggiare il problema in vari modi. Alcuni, come il Massachusetts, seguirono una politica dura contro quei contadini che si rifiutavano di pagare. In molti di questi stati i contadini presero le armi. La più seria di queste crisi eruppe con violenza proprio nel Massachusetts dove la Rivolta di Shay fu repressa nel 1787. Altri stati, come il Rhode Island, tentarono di aiutare i contadini emettendo moneta legale, insistendo affinché i creditori l’accettassero, anche se erano residenti di altri stati. Mentre politiche di questo tipo pacificarono i contadini dell’ovest, aumentarono le tensioni tra stati.” Instabilità politica, dunque. Da qui l’inserimento nella Costituzione di un solo emittente monetario per tutti: una condizione necessaria, quella della moneta unica, per raggiungere la desiderata unione politica. Ma non sufficiente.
Le cose non furono infatti tutto rose e fiori, anzi. Il parallelo con la storia sofferta di questi primi anni dell’euro, a rileggerli, è straordinario: “Lungo l’arco (almeno) dei suoi primi 150 anni di unione monetaria, gli Stati Uniti sono stati sconvolti ripetutamente da gravi dispute tra stati o regioni sulla politica monetaria e le sue istituzioni. In più di un’occasione tali dispute contribuirono a creare incertezza sul futuro delle politiche e delle istituzioni che, a sua volta, esacerbò i disturbi economici e contribuì agli errori nella politica monetaria nazionale. Queste dispute regionali sulla politica monetaria nacquero a causa di divergenze reali negli interessi tra stati o regioni: quella che poteva essere una buona politica monetaria dal punto di vista di uno stato o di una regione era a volte la politica sbagliata dal punto di vista di altri. Le dispute più aspre avvennero allorquando relazioni monetarie avverse si svilupparono in uno stato/regione che già soffriva di uno shock reale. Un declino nella domanda di prodotti agricoli, ad esempio, deprimeva i redditi, portando a sua volta a una serie di crisi bancarie e corse ai depositi, e ad un declino statale/regionale nell’offerta di moneta, che rafforzava l’effetto dello shock iniziale. Riassumendo, uno storico economico che sia alla ricerca di prove del costo di cedere la propria sovranità monetaria può trovarne in abbondanza nella storia monetaria degli Stati Uniti”.
*
Dopo aver documentato un numero notevole di casi di questo tipo nel XIX secolo statunitense, Rockoff si chiede se l’unione monetaria tra questi stati debba essere ritenuta ottimale. Per avere vantaggi da una moneta in comune gli stati unitisi avrebbero dovuto essere: relativamente “piccoli”, non specializzati nella produzione di certi beni e non soggetti a shock asimmetrici, con ampia mobilità del lavoro e del capitale con gli altri stati e con la possibilità di ricevere trasferimenti fiscali da altri stati.
Ma, argomenta lo storico, gli stati USA erano tutto il contrario: erano economie piccole, soggette a shock regionali specifici, in cui quanto a “mobilità del lavoro il Sud fu un mondo a parte fino alla seconda guerra mondiale” e, soprattutto, per le quali nel XIX secolo il governo federale di Washington era “semplicemente troppo piccolo come quota di PIL per compensare shock regionali tramite trasferimenti fiscali”. Vi ricorda qualcosa? Già, gli stati dell’Europa dell’euro in cui a Bruxelles mancano le risorse di bilancio per aiutare i singoli stati in difficoltà.
E’ solo nel 1930 – con l’introduzione di politiche di solidarietà verso gli stati più in difficoltà, ideate da Franklin Delano Roosevelt tramite trasferimenti fiscali dagli stati ricchi a quelli più poveri – che nascono gli Stati veramente Uniti d’America e il dollaro può dirsi un collante di successo economico. Ma anche allora, 150 anni dopo la nascita dell’Unione, qualcuno ebbe modo di rimpiangere l’assenza di autonomia monetaria: “certe regioni degli Stati Uniti esibirono chiaramente molti dei segni che posseggono i candidati ideali per monete separate, almeno fino agli anni Trenta …la soluzione ottimale, fosse stata fattibile politicamente, avrebbe potuto essere quella di monete separate tra Est, Ovest, Sud and la Costa del Pacifico”. In realtà, anche nella crisi degli anni 30, una banca centrale autonoma della grande regione del Midwest avrebbe fatto meglio per se stessa, sotto la pressione degli interessi locali, con una politica ancor più inflazionistica di quella che fece la Fed nell’epoca di Roosevelt: svalutando la mai nata moneta locale avrebbe aiutato maggiormente il suo settore manifatturiero, “il più colpito di tutta la Nazione”; “riassumendo, l’unione monetaria, che in tempi stabili era una fonte di forza per gli Stati Uniti, appare essere stato un peso negli anni Trenta”.
*
Fate le vostre analogie con la nostra crisi europea di questi anni: sono analisi che ci portano ad essere a favore del ritorno alla liretta? Mica così semplice. Continua Rockoff, guardando agli Usa, malgrado i costi della valuta unica, affermando: “ovviamente valute separate erano escluse da considerazioni politiche. Una valuta è il simbolo della sovranità, come la bandiera, ed è difficile immaginare un qualsiasi Paese che scelga deliberatamente di adottare valute diverse”.
Un “ovviamente” che vale meno per un’Europa dell’euro che ancora non sa qual è il valore della sua bandiera a stelle gialle. E l’Europa non è ancora un “Paese”; noi non siamo l’America degli anni trenta, con alle spalle quei 150 anni di lento ma continuo convivere insieme degli stati.
Il paragone che noi dobbiamo fare non è con l’unione del dollaro odierna ma con l’unione monetaria di quegli Stati Uniti del XIX secolo, appena nata, con stati diversissimi tra loro, in cui l’ambizione politica di unirsi si scontrava con i costi economici dello stare insieme per l’incapacità ancora di esercitare solidarietà reciproca.
E che lezioni trae il nostro autore da tutto ciò per l’Europa? Correva, al momento della scrittura del suo saggio, il 2000. Un anno in cui l’unione monetaria europea non aveva ancora messo a nudo le debolezze che ora è facile riconoscere. Quindi è ancor più interessante analizzare le sue conclusioni, non indebolite da quel “senno di poi” tipico di tanti analisti che diventano saggi dopo il fatto.
“Per un paese che sta valutando se entrare a far parte di una unione monetaria la lezione è che l’argomento superficiale, che siccome gli Stati Uniti hanno avuto una unione monetaria allora le unioni monetarie sono una cosa buona, non regge ad uno scrutinio più accurato. Bisogna pensarci un po’ di più. Per paesi invece già convintamente parte di una unione monetaria, la lezione è che è estremamente importante adottare quelle istituzioni che gli Stati Uniti hanno adottato negli anni Trenta – un sistema di trasferimenti interstatali e qualche forma di assicurazione dei depositi… – così che shock asimmetrici reali non vengano aggravati da crisi bancarie.”
Certamente, tutto vero, ma quanto tempo ci misero gli Stati Uniti a convincersi a fare le politiche giuste per tutti loro? “Quanto ci misero gli Stati Uniti d’America a diventare un’area valutaria ottimale? Una stima ragionevole minima è di 150 anni! Sperabilmente non ci vorrà così tanto per l’Unione Monetaria Europea”.
*
Ma forse sì. E dobbiamo essere pronti a imparare, da questa ottima analisi, due cose. Primo, che se le vogliamo capire e prevederne il destino, dobbiamo accettare l’evidenza che le unioni monetarie seguono logiche diverse da quelle che gli vogliono affibbiare gli economisti con il loro limitato concetto di efficienza, sviluppandosi esse attorno a progetti ben più complessi politicamente, come acutamente faceva notare il compianto maestro Marcello De Cecco nella citazione all’inizio di questo post. Secondo, visto che prima che si creino le istituzioni giuste per sostenere una unione monetaria ottimale che non generi danni economici ci vuole tanto tempo, se veramente si intende sperare che il progetto politico dell’euro resista e non si sfaldi prima o che magari lo si “salvi” con una drammatica guerra civile interna all’Europa, bisogna fare dei realistici ma continui passi in avanti.
I lettori di questo blog sanno bene che non crediamo nella possibilità di vedere nei prossimi trent’anni nascere trasferimenti fiscali diretti tra tedeschi e greci o italiani. Come per l’America del XIX secolo, non vi sono le basi culturali per permetterlo, ancora troppo diversi i cittadini di ogni Stato europeo e troppo eterogenei i loro interessi economici.
E allora dobbiamo trovare degli elementi di minore ambizione che permettano di guadagnare tempo, dando al collante culturale il tempo di agire. L’abolizione del Fiscal Compact, una politica fiscale ancora decentrata a livello di stati nazione ma più espansiva di quella odierna è quello che può servire: più modesto del progetto di Roosevelt, ma destinato con maggiore probabilità a non fallire. Per un Roosevelt europeo, c’è tempo, speriamo meno di 150 anni.
Muoviamoci dunque in questa direzione, contro l’austerità, gettando le basi di una vera costruzione comune europea. Così che un giorno i figli dei figli dei nostri figli possano vivere in un mondo sì iper-globalizzato ma dove i valori dell’Europa siano rappresentati con forza e autorità, e non dominati da una concezione culturale a noi estranea – selvaggia, come direbbe De Cecco – che soffoca le nostre aspirazioni.