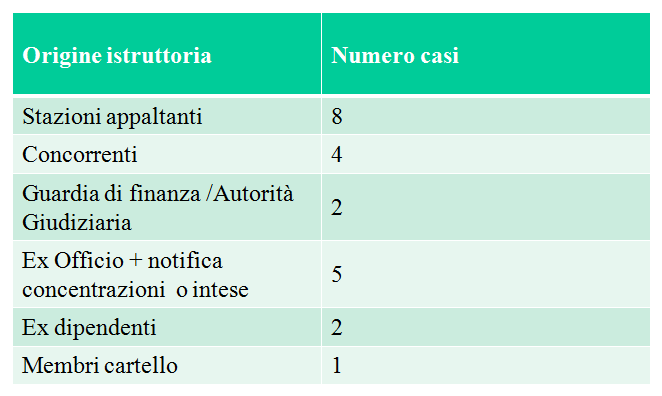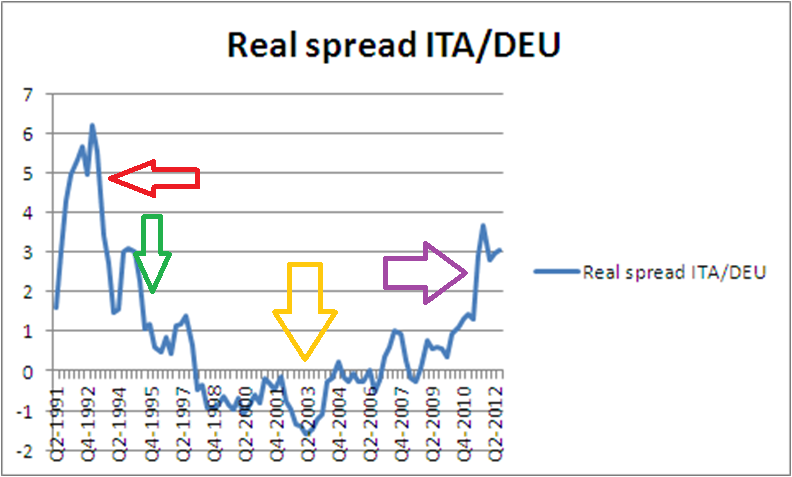Oggi, nel silenzio generale di un Paese che ha altre cose a cui pensare, si è chiusa ufficialmente la finestra temporale per tantissimi giovani e meno giovani ricercatori e professori universitari per partecipare al bando di abilitazione nazionale, condizione necessaria per la promozione di carriera.
Stefano mi dice che quando ha chiuso la sua domanda il sito gli ha affibbiato il numero ottantantamila e passa. Se ogni candidato ha fatto in media due domande, su due settori scientifici disciplinari diversi, parliamo di circa quarantamila persone che aspettano con giustificata ansia che si avvii un meccanismo che permetta di aspirare ad un salto di carriera.
Quarantamila persone. Tutte on line a fare domanda, a inserire i loro lavori sul web, scannerizzati. Molti giovani. Moltissima burocrazia. Controlli a tappeto. Se dovessi essere eletto commissario dovrò leggere chissà quanti lavori di giovani bravi e meno bravi, invece di selezionare quello che già so sarebbe utile alla mia università, liberamente, senza concorsi, per poi essere valutato sulla sua qualità e ricevere finanziamenti solo se effettivamente avevo avuto ragione a selezionarlo. Ma no, facciamo i mega concorsi farsa.
E intanto il mondo va. Senza ottantatamila domande sul web.
Mentre il mondo va, la nostra università sta. Ferma sta.
Senza che nessuno parli di come convincere i nostri giovani, così ben preparati da mietere successi all’estero, a rientrare dopo la giusta esperienza all’estero, fatta anche per aprire gli occhi, quando il primo nostro stipendio è di 3 o 4 volte inferiore al primo stipendio che offre lo straniero.
Senza che nessuno al vertice scommetta sull’Italia come volano di export di formazione, in cui i nostri campus universitari si attrezzino con quelle poche noccioline di qualche miliardo di euro ad avere residenze universitarie per accogliere migliaia di studenti stranieri desiderosi di pagare rette da 10.000 euro pur di formarsi da noi. E che invece finiscono in Francia, o in Svizzera. Perché non abbiamo, oltre alle residenze, i programmi in lingua inglese.
Questo Governo non ha fatto nulla per cambiare l’Università, mentre la riforma Gelmini dimostra ogni giorno di più la sua vera natura: una riforma gattopardesca. Senza impatto. Mediocre.
Gli assenteisti a lezione, tra i prof, sono sempre lì. Come sono sempre lì quelli che dovrebbero insegnare 120 ore per contratto e ne fanno la metà, magari a classi con pochi allievi perché non si sporcano le mani con tanti studenti. E quelli che fanno fare lezioni ai loro studenti o ricercatori ma si tengono il nome del corso sono ancora lì, tranquilli.
Nella mia (ex) Facoltà i Dipartimenti – ora nuovi centri che dovevano cambiare in maniera “epocale” il modo in cui si fa ricerca in Italia – si dividono tra loro in risse inutili e ridicole. Un giovane ricercatore ieri al bar mi parla di “noi” e “voi”, manco fossimo Israele e Palestina. Come al solito quando ci sono solo briciole, i poveri si fanno la guerra tra loro.
Nessuno parla di centralizzare gli uffici acquisti degli Atenei per risparmiare ed investire, mentre i programmi di insegnamento migliori non sono premiati, esattamente come i programmi peggiori.
Le statistiche sul nostro tasso di laureati ci relegano al margine del mondo. Mentre sempre meno giovani si immatricolano (288.000 nel 2010, contro i 294.000 nel 2009), manca un piano nazionale che individui i giovani più talentuosi alle medie e li segua nel loro percorso liceale. I più bravi al liceo non sono indirizzati in funzione del loro voto di diploma verso le scelte più prestigiose anche perché non esiste, come in Turchia, un premio per chi ha fatto bene a scuola, tale da poter scegliere per primo a quale università iscriversi.
Se i Viaggiatori in movimento fossero al governo dell’Università farebbero in pochi anni quello che nessun Governo ha voluto fare in tutti questi anni: premiare il talento (che c’è, eccome, e che può essere attratto ancora di più), organizzare le strutture, trovare i fondi nei risparmi realizzati e nei ricavi da espansione verso l’estero, insegnare bene, controllare che si insegni bene, ricercare bene. Senza l’ipocrisia di centinaia di concorsi e controlli finti ma facendo arrivare i soldi a quelli che assumono i più bravi, liberamente, senza concorsi.
Lo dico perché stiamo scrivendo una possibile riforma, da fare in qualche mese, che cambierebbe tutto: la cosa più sconvolgente è quanto sarebbe facile provare a farlo. La pubblicheremo nel programma dei Viaggiatori. Ma il punto non è questo: il punto è la mediocrità assoluta, banale, di chi ci governa senza un filo di idee, di voglia di cambiare, di innovare, di stupire. La stasi.
La mediocrità di questo Governo come dei precedenti, nell’Università, impera. E mentre il mondo va avanti, noi, fermi, arretriamo. Sveglia, si può fare. Non tutto è Gattopardo.