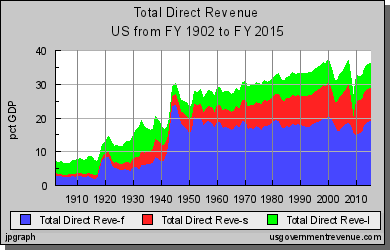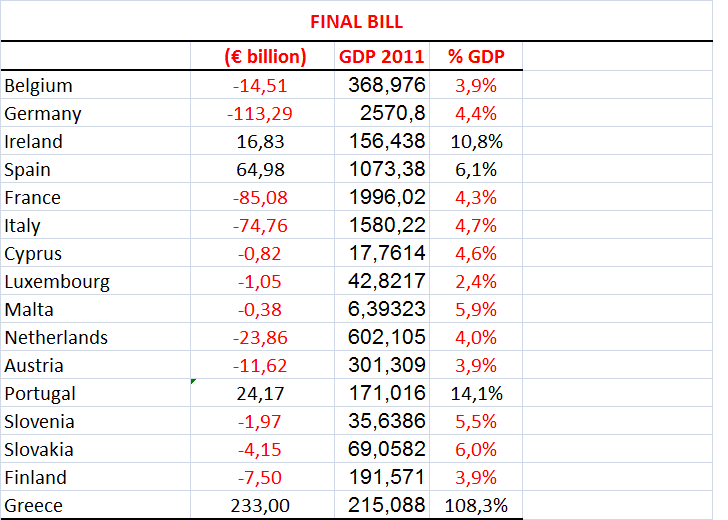Ci risiamo. Non posso farci niente, sono io che sono allergico. Non ce la faccio più, è evidentemente più forte di me, ma ogni volta che leggo piccolo è brutto, perdo la trebisonda.
Ci risiamo. Non posso farci niente, sono io che sono allergico. Non ce la faccio più, è evidentemente più forte di me, ma ogni volta che leggo piccolo è brutto, perdo la trebisonda.
Se poi lo si fa davanti ai piccoli, lo trovo particolarmente difficile da digerire.
Se poi lo si fa davanti ai piccoli del Veneto, il grande Veneto dei piccoli imprenditori, beh, allora scusate, ma la misura è colma.
Sì, sì, parlo di piccoli imprenditori. Quelli veneti nel caso di specie. Quelli che soffrono come non mai. Quelli dei tanti suicidi, ma anche del credito che non c’è più e del debito della pubbliche amministrazioni che viene pagato in ritardo. Quelli là.
Quelli che fanno l’Italia dell’export. Quelli che, come ha detto il Direttore Generale della Banca d’Italia Fabrizio Saccomanni alla presentazione a Venezia del rapporto sull’economia del Veneto, garantiscono la maggiore internazionalizzazione (export di beni su PIL) all’interno del Paese.
Peccato però che Saccomani abbia detto di più.
La sfida impone scelte difficili al nostro sistema delle imprese: l’epoca del “piccolo è bello” è finita per sempre. La piccola impresa familiare, con modesto utilizzo di risorse tecnologiche e manageriali, non ha futuro nella competizione globale. Gli imprenditori devono orientarsi verso strategie ambiziose, volte a favorire la crescita dimensionale.
Se io fossi stato un piccolo imprenditore veneto mi sarei risentito. Ci ho messo poco a scoprire che avevo ragione. Basta fare qualche clic sul web ed eccoci sul sito della CGIA, l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre dove leggo il commento pacato del Presidente della Cassa alle parole di Saccomanni:
Ma nella presentazione della situazione economica del Veneto non è mancata nemmeno una dura critica al nostro sistema economico: ‘l’epoca del “piccolo è bello” è finita per sempre’. Su questa affermazione mi permetto di sollevare qualche perplessità. Innanzitutto perché il problema del nostro territorio non è legato al fatto che ci sono troppe piccole imprese, caso mai è riconducibile all’assenza delle grandi imprese che in questi ultimi trent’anni sono sparite quasi completamente, non certo per colpa delle piccole aziende o del destino cinico e baro, ma per il fatto che il mercato ha operato una selezione durissima spingendole fuori mercato. In secondo luogo mi permetto di sottolineare che le piccole imprese, pur con tutti i limiti e le difficoltà, costituiscono uno straordinario patrimonio invidiatoci in tutta Europa. Si pensi che l’importanza del mondo delle micro e delle piccole imprese è ormai riconosciuto anche dall’Ue che ha rilevato che nel 2011 il 58% dei nuovi posti di lavoro è stato creato dalle imprese con meno di 10 addetti. Ritenere che queste piccole realtà costituiscano un limite per la tenuta e lo sviluppo del nostro territorio mi sembra un vero e proprio azzardo.
Io che non ho ruoli istituzionali ci vado giù un po’ più duro. Altro che azzardo. Ed in realtà, per correttezza, preciso che il Direttore Generale poco dopo si riprende in parte, quando dice che “le misure governative possono in primo luogo affrontare gli ostacoli di natura normativa che impediscono la crescita dimensionale delle imprese”. Ecco, dire “crescere è bello” forse è meglio di dire “piccolo è brutto”: perché aiuta a comprendere che quello di cui abbiamo bisogno è aiuto alle piccole.
Ma la frittata è fatta. Le parole uscite non tornano indietro, rimangono stampate di color nero, tradiscono un approccio. Nell’approccio di Banca d’Italia c’è – per primo – poca attenzione all’inefficacia del sistema bancario rispetto alle PMI in questa crisi, che forse avrebbe dovuto essere l’unico tema che a Saccomanni spettava approfondire: “Il sistema bancario deve fornire un contributo importante al processo di crescita dimensionale, sviluppando l’attività di assistenza alla clientela nell’accesso diretto al mercato dei capitali e accompagnando le imprese nell’attività di internazionalizzazione”.
Comunque troppo poco.
Mi è più utile leggere le parole del Presidente della CGIA: “va sottolineato che le sofferenze tra le imprese venete presentano valori molto diversi a seconda della dimensione delle imprese. Premesso che l’80% circa dei prestiti erogati alle aziende va al primo 10% dei maggiori affidati (cioè ad una cerchia molto ristretta di clientela), sempre in capo a questo 10% ricade anche l’80% circa delle sofferenze. In buona sostanza la stragrande maggioranza dei soldi va ai grandi gruppi economici che, stranamente, presentano livelli di solvibilità molto bassi. Sia chiaro: questa specificità non è riscontrabile solo nel Veneto, purtroppo è una caratteristica diffusa in tutto il Paese, a dimostrazione che in Italia le banche prediligono i rapporti con le grandi società, i potentati economici ed i grandi gruppi industriali. D’altronde, non è un caso che nei consigli di amministrazione dei grandi istituti di credito siedano manager, capitani d’industria o uomini comunque riconducibili a questi grandi gruppi.”
Se cercate sulla rete troverete anche uno studio del 2011 sullo stato delle piccole imprese venete in un momento, il 2011, in cui appaiono leggermente ottimistiche, prima che tutto peggiorasse nuovamente. E sapete cosa dicono queste imprese?
L’indagine VenetoCongiuntura ha consentito inoltre di misurare quali sono i tre problemi più sentiti dagli imprenditori per il 2011. I risultati confermano che i temi più “scottanti” per le aziende venete sono i ritardi nei tempi di pagamento, la difficoltà nell’accesso. al credito e la stagnazione della domanda. Nelle micromprese il problema principale segnalato è stato quello dei ritardi nei tempi di pagamento, dichiarato da quasi il 44 per cento delle aziende come primo problema, dal 31 per cento come secondo problema, mentre dal 13 per cento come terzo. L’accesso al credito è risultato un’altra grave difficoltà: infatti il 33 per cento degli imprenditori lo considera il primo problema, il 41 per cento il secondo e il 20 per cento il terzo. Nella classifica delle problematiche troviamo poi la stagnazione della domanda, indicato dal 32 per cento degli imprenditori come primo problema, dal 29 per cento come secondo e dal 22 per cento come terzo.
Ecco. Se nel 2011 oggi era così, pensate il 2012 a come un’esplosione esponenziale di queste tre criticità a cui per ora non è stata data soluzione: né dalla Banca d’Italia (i prestiti), né da Passera (i ritardi di pagamento), né dall’Europa (la domanda aggregata via domanda pubblica).
Certo, Saccomanni non è ignaro del fatto che “spetta, inoltre, all’azione di governo migliorare il contesto istituzionale in cui operano le aziende”. E che “tutte le misure di intervento in grado di rendere i servizi pubblici più efficienti ed efficaci migliorano la competitività”.
Ma mai, mai una volta nel suo discorso sentiamo il calore di una posizione culturale capace di comprendere che piccolo è bellissimo perché nuovo, perché potenzialmente rivoluzionario e innovativo, e che dunque va protetto come negli Stati Uniti e come si proteggono i nostri bellissimi bambini, introducendo regolazione differenziata e domanda pubblica ad esse riservata (sì appalti) per colmare il gap di pari opportunità che alle piccole viene negato.
Che “piccolo è bello perché la natura umana è bella”, come diceva Ernst Schumacher.
Fino a che ai grandissimi piccoli imprenditori veneti non diremo “grazie per quello che fate e scusate se siamo stati, noi regolatori e politici, finora inadatti e non alla vostra altezza, non lo faremo più”, non partirà mai la rivoluzione di crescita culturale ed economica italiana.
 Dice il Nobel Sargent
Dice il Nobel Sargent