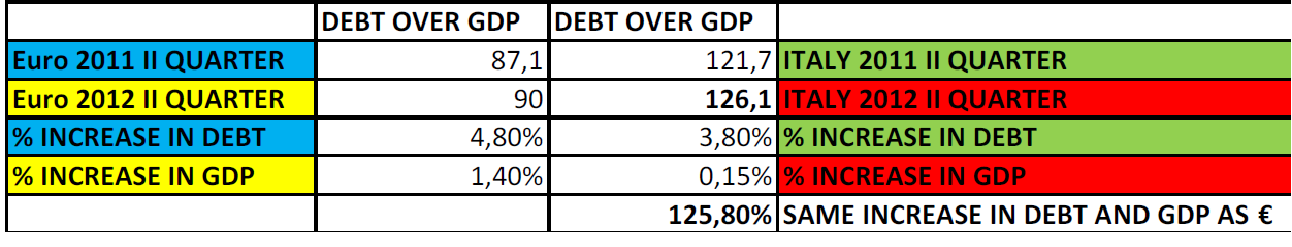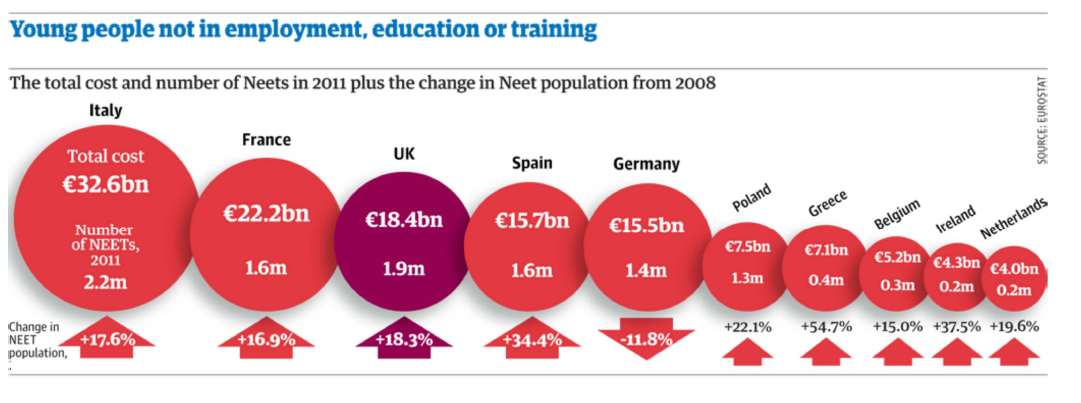Al confronto scontro tra viaggiatori e fermatorideldeclino l’altro giorno in facoltà a Tor Vergata, molto bello, alcuni studenti si sono lamentati che si è parlato troppo di politica e poco di economia. Un altro studente mi ha detto, “se siete d’accordo sul 70% delle cose, perché non vi alleate per il bene del Paese e mettete da parte le vostre differenze” (che sono molto minori, diceva sempre lui, di quelle che vi separano da altri?).
Ho pensato molto a queste frasi. Se devo generalizzare, ritengo i fermatorideldeclino dei liberisti. Nei viaggiatori invece ci sono una marea di posizioni, e trovo sia un bene fecondo. La mia tuttavia è quella di un liberale “protezionista”, molto diversa da quella di un liberista. Mi spiego qui sotto su questa differenza di posizioni e sulla domanda su politica e economia.
*
E’ possibile rispondere no alla domanda “la concorrenza fa bene?”. Luigi Einaudi sosteneva la liceità della domanda. Ne “Ipotesi astratte ed ipotesi storiche e dei giudizi di valore nelle scienze economiche” nel 1943 così si pronunciava:
“Il diritto di limitare i propri studii all’investigazione delle leggi del prezzo in regime di concorrenza piena … non implica dunque l’affermazione, ben diversa, che la scienza finisca a quel punto e che gli sforzi altrui intesi ad investigare se l’attuazione della concorrenza piena … sia o non sia conforme ad un certo ideale di vita cadano fuori dal territorio scientifico.”
Che nello stesso saggio continuava: “Se le premesse ed i ragionamenti degli economisti furono fecondi di grandi risultamenti scientifici, grazie debbono essere rese anche ai loro ideali di vita. Consapevolmente o non, essi possedevano e posseggono un certo ideale; ed in relazione ad esso ancor oggi pensano e ragionano.” Naturalmente Einaudi non si esime dal manifestare quali fossero i suoi ideali: “Chi, al par dello scrivente, aborre dall’ideale comunistico o plutocratico-protezionistico non può fare a meno di palesarsi fautore dell’ideale liberale”. E qui, e chiudo con le citazioni, vi è un rimando ad una nota meritevole di essere ricordata: “Liberale e non liberistico ché liberismo è concetto assai più ristretto sebbene abbastanza frequentemente compatibile col liberalismo; ed ha un contenuto concreto di applicazione, in particolare a certi problemi soprattutto commerciali e doganali. Il liberalismo implica un ideale di vita e vien fuori da imperativi morali assoluti (la cui condizione fondamentale è quella della libera scelta da parte degli uomini dei proprii fini e quindi anche dei propri consumi)”.
Come vedete, l’economista Einaudi aveva ben chiaro che per porre un problema economico bisognava esprimere dei giudizi di valore politici. L’economia nel vacuo dell’ideale è nulla perché non rimanda a dei valori.
Quindi per Einaudi il liberismo (la concorrenza) non è né condizione sufficiente né necessaria per perseguire l’ideale del liberalismo. Tema d’attualità, visto che si ha spesso l’impressione di vivere in un’area geografica, l’Unione Europea, che ha fatto del liberismo economico, della concorrenza, un’ideale di vita. Non uno strumento, come lo intendeva Einaudi, funzionale, quando può (e spesso può), all’ideale del liberalismo, quello di rimuovere le barriere alla libertà di scelta degli individui. E questo è un male. Gli esempi non abbondano, ma non sono nemmeno pochi. Ne cito alcuni, cercando di provocarvi un po’.
Primo, la concorrenza nel mercato del lavoro. Sia Smith che Einaudi hanno sempre messo in guardia da riforme che introducessero eccessiva concorrenza nel mercato del lavoro. Smith si preoccupava dell’eccessivo potere delle imprese rispetto ai lavoratori; Einaudi raccomandava la nascita di grandi gruppi confederali da un lato e l’altro del mercato: “l’organizzazione perfetta delle leghe padronali e delle leghe operaie allontana il pericolo degli scioperi e dei conflitti violenti”. Entrambi temevano, anche se per motivi diversi, un’asimmetria di potere contrattuale tra le parti, così estrema, da essere portati a giustificare la nascita di associazioni volontarie dei lavoratori ed imprenditori volte a confrontarsi. Associazioni volontarie che invece, come ben sappiamo, sono vietate tra imprenditori dalle leggi Antitrust quando si tratta di decisioni sul quanto produrre ed a che prezzo, proprio per non generare un eccessivo potere contrattuale a scapito dei consumatori. Un’asimmetria tale, e torno al mercato del lavoro, una tale debolezza di una delle parti rispetto all’altra, da svuotare il concetto di libertà di scelta da parte dei lavoratori, e quindi intollerabile per un liberale.
In effetti, a guardare i dati, esiste pochissima evidenza empirica che là dove i mercati del lavoro divengono più concorrenziali (flessibili diremmo noi) indebolendo le protezioni per i lavoratori le prestazioni dell’economia migliorano. Il Premio Nobel Robert Solow si spinge addirittura a dire che anche se tali miglioramenti avvengono non sarebbero desiderabili se generano troppa insicurezza sul posto del lavoro per il lavoratore.
Eppure non è questa l’enfasi che proviene da Bruxelles, specialmente dalla Commissione Europea, che si spinge fortemente in avanti sul tema invece della flessibilità.
Esempio numero due. Gli appalti pubblici. Negli Stati Uniti, dal 1953, Amministrazione Eisenhower, la partecipazione alle gare d’appalto delle piccolo imprese è protetta da un notissimo Atto, lo Small Business Act, che riserva un minimo di 23% degli acquisti pubblici alle Piccole imprese (fatturato inferiore a 750.000 dollari annui). Val la pena citare le apparentemente contradditorie parole di apertura dell’Act: “L’essenza del sistema economico privato americano è la libera concorrenza. Preservare ed espandere tale concorrenza è basilare non solo per il benessere ma anche per la sicurezza della Nazione. Tale sicurezza e benessere non possono essere realizzati a meno che l’attuale e potenziale forza delle piccole imprese non sia incoraggiata e sviluppata.”
Al di là dell’accostamento tra sicurezza e benessere economico (la nazione ricca è una nazione forte e dunque sicura) su cui tornerò tra poco, merita qui notare che viene accordata alle piccole una protezione che impedisce alle grandi imprese di liberamente partecipare ad alcune gare d’appalto. Tale protezione è, di nuovo, basata sul rimuovere una chiara asimmetria di potere contrattuale, questa volta tra piccole e grandi imprese che hanno capacità diverse in partenza per partecipare a gare d’appalto, e ciò è confermato dal fatto che tale protezione è estesa ad imprenditori appartenenti a minoranza etniche.
E in Europa? Oggigiorno la Direttiva Europea sugli appalti (anche l’ultima di prossima approvazione) esclude la possibilità di prevedere che una quota degli appalti pubblici sia riservata e destinata esclusivamente alle piccole e medie imprese. Il problema appare gravissimo nei nuovi Paesi membri dell’Unione Europea che hanno appena aperto completamente il loro mercato delle commesse pubbliche alle grandi imprese estere multinazionali.
Siamo di fronte ad un apparente paradosso: una politica liberale, quella degli Stati Uniti, che restringe la concorrenza; da paragonare ad una politica puramente liberista europea.
Questi due esempi sintetizzano efficacemente le ragioni dello scetticismo che circonda da qualche tempo la costruzione europea, apparentemente slegata da un qualche ideale e votata a raggiungere testardamente un mero risultato tecnico-economico spesso slegato da un’analisi piena del suo impatto ultimo.
Le quote rose al femminile e la quota lattanti da me proposta ieri fanno parte di queste tutele necessarie per ridurre l’asimmetria del contratto sociale all’interno del Paese in cui viviamo, in cui la discriminazione verso donne e giovani è evidente.
Vi è infine la questione della contendibilità di alcuni settori considerati strategici rispetto all’interesse economico di controparti estere e dunque della concorrenza non tanto tra imprese ma riguardante la proprietà delle imprese. Dobbiamo per forza aprire le nostre imprese del settore della difesa, le nostre imprese energetiche, telefoniche, bancarie ad acquisizioni da parte di stranieri? Rispondere no a questa domanda significa evidentemente non essere considerati come liberisti.
E’ giusto allora parlare di limitare la concorrenza proprietaria verso l’estero?
Mi sembra che si possa tranquillamente dire sì nel caso del settore della difesa e dell’energia senza tradire il credo liberale. E anche qui per non generare eccessiva asimmetria nelle posizioni contrattuali, in questo caso dei nostri cittadini rispetto a quelli di altri Stati. Nella difesa, cedere un’azienda chiave in mani estere significa cedere significative porzioni di informazioni strategiche, che generalmente si vogliono mantenere segrete e quindi indebolirsi come Paese in termini di protezioni dei confini nazionali. Così come ci si indebolisce nel momento in cui le priorità energetiche del Paese vengono sacrificate alle priorità di altri Paesi a cui l’azienda in mano estera è più sensibile.
Indipendenza energetica. Se e nei limiti in cui il concetto di libertà dei cittadini di un Paese è messo in pericolo dal possesso straniero di tali aziende non vedo perché un liberale non debba opporsi alla contendibilità di tale imprese.
Se così è, estenderei – anche se con meno passione e convinzione – questi ragionamenti al settore delle telecomunicazioni e al settore bancario.
Per un Governo che deve garantire la sicurezza interna con controlli e spionaggio anti-crimine e/o anti-terroristismo, anche via rete telefonica, è pensabile che ci si possa preoccupare di mantenere perlomeno un carrier nazionale.
E che dire del settore bancario? Esiste abbastanza evidenza empirica che dopo le fusioni tra banche di diverse nazionalità il mercato dei servizi non diventa più concorrenziale di prima dato che gli stranieri si adattano alle pratiche del mercato interno. In assenza di benefici evidenti per i consumatori, come non preoccuparsi di una proprietà straniera che – o per motivi politici o per motivi di asimmetria informativa – presterà meno alle nostre piccole imprese con il nostro risparmio? Se, come sostengono gli americani, benessere economico comporta sicurezza, come non preoccuparsi di una proprietà che ovviamente non è neutrale nelle sue scelte e che sbilancia il potere contrattuale a favore delle imprese estere e contro le nostre (specialmente piccole) imprese? E non si pensi che tale atteggiamento sia da denunciare come provinciale: a parte il Regno Unito (che basa il suo sviluppo economico sul divenire la piazza finanziaria mondiale) gli altri Paesi sviluppati, inclusi quelli dell’Unione Europea, non sono più esterofili di noi quando si tratta di aprire la proprietà delle banche.
Si dirà che siamo in Europa e che quindi dobbiamo ragionare così solo verso i paesi fuori dall’Unione Europea. Può darsi. Allora a questo punto ricorderei che tali acquisizioni vanno legate strettissimamente al concetto di reciprocità.
Se così non fosse, finché alla cultura dello sviluppo europeo non si affianchi lo sviluppo della cultura europea che porti ad un Governo politico europeo, bene facciamo a proteggere le nostre libertà coltivando campioni nazionali non contendibili.
Più di ciò non riesco immaginare contro la concorrenza: da qui in poi ha inizio il territorio vasto e fertile in cui liberismo e liberalismo vanno a braccetto ed in cui va tenuta, alta e bene in vista, la bandiera della concorrenza.
Ma, come potete ben capire, non è facile ridurre queste differenze e sedersi al tavolo di una visione di programma comune.