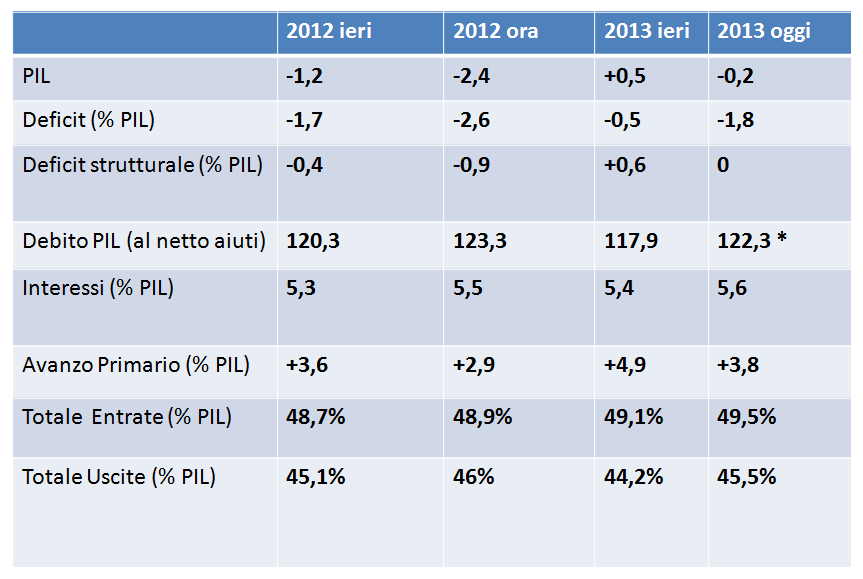La questione dunque che le varie Regioni Lazio d’Italia pongono drammaticamente è quello della spesa pubblica. Poco importa se la corruzione, i conflitti d’interesse, le frodi, la poca integrità si annidano nella politica o nella burocrazia: è evidente che le due si sostengono a vicenda. Un burocrate che opera sotto un politico corrotto troverà più conveniente corrompersi a sua volta, ed un politico che opera con un burocrate corrotto sotto di lui troverà più semplice mandare avanti i suoi progetti corrotti.
La questione della spesa pubblica, dunque, o meglio dell’incapacità di politici e burocrati di gestirla per la cittadinanza. E quindi, secondo alcuni, dell’inevitabile esigenza di ridurla. Attenzione non di riqualificarla: di ridurla. Non di individuare gli sprechi e usare le risorse così ottenute per sostenere l’economia nel breve e lungo periodo. No, una vera e propria ritirata dello Stato dall’economia.
E’ stato utile a questo riguardo ascoltare il responsabile economico del PD, Stefano Fassina e il mio collega Francesco Giavazzi sfidarsi elegantemente ma anche intensamente davanti a Lilli Gruber ad 8 e mezzo su La 7. Se l’avete perso, vi consiglio di vederlo.
La posizione di Fassina è semplice: non bisogna tagliare, bisogna riqualificare. E ricorda correttamente che la presenza della spesa pubblica nell’economia italiana, se non si considerano i trasferimenti – interessi e pensioni - che spesa pubblica e PIL non sono perché non generano beni o servizi - è minimale quando paragonata a quella degli altri paesi dell’Unione europea.
La posizione di Giavazzi è altrettanto semplice: Svezia e Danimarca spendono più di noi, ma efficientemente, così che l’economia cresce (lo riconosce) ma non crede che noi italiani lo si sappia fare e, dunque, questa spesa pubblica va ridotta. Visto che come gli scandinavi non saremo mai, meglio abbatterla e goderci perlomeno la riduzione delle tasse che ne otteniamo.
E’ contestabile sotto due punti di vista la posizione di Giavazzi. Primo, esprime una totale mancanza di fiducia verso questo Governo e nella sua capacità di riformare la qualità della spesa pubblica, che lui stesso vede come fattore di crescita. Ne prendiamo atto, anche perché ciò significa che la spending review italiana (come alla fine ammettono sia Fassina che Giavazzi) non è fatta per individuare gli sprechi ma per tagliare la spesa e basta: e cioè esaltando la componente recessiva dei tagli (ricordo per la decima volta o forse più che tagliare gli sprechi non è recessivo, tagliare la spesa buona, pari allo 80% di essa, sì).
Su questo blog e su quello dei viaggiatori sapete quante volte abbiamo chiesto al Governo di dare prova che veramente si faceva sul serio nel tagliare non la spesa ma gli sprechi: risposte mai ricevute, ma rimaniamo ottimisti.
Secondo, Giavazzi pare sottolineare come i Governi non si possano modificare dal di dentro, auto- riformarsi. Non è così. Non fu così quando il Regno Unito, prima con Thatcher e con Blair, riformarono una burocrazia incancrenita. “Ma no, noi non saremo mai come il Regno Unito” direbbero i giavazziani anti-declinisti.
Non ce n’è bisogno. Basta essere come l’India. La cui polizia è nota per corruzione, sprechi ed incompetenza ma che, mostrano cinque economisti di grande valore, di cui due del MIT di Boston, ha mostrato di sapersi migliorare con riforme opportune venute dall’alto.
Vediamoli i dati indiani, analizzati dagli autori. Dove prima delle riforme solo il 29% delle vittime di crimini se la sente di denunciare il reato subìto e, tra quelle che denunciano, ben il 17% viene scoraggiato dal depositare la denuncia. Dove il 62% delle vittime si è dichiarato molto o abbastanza insoddisfatto di come il caso è stato trattato dalla polizia, con la percezione (82% di loro) che la polizia non ha fatto nulla di speciale non interessandosi al loro caso. Solo il 9% degli intervistati ha mai avuto un’interazione con la polizia in tutta la propria vita (3% le donne), a parziale conferma della sfiducia della cittadinanza.
Con un esperimento assai capillare lo Stato del Rajasthan ha (su di una popolazione uguale a quella della Danimarca) provato ad effettuare 5 riforme per migliorare l’impatto dell’azione di polizia sulla vita quotidiana dei cittadini: 1) la sospensione dei (frequenti) spostamenti amministrativi dei poliziotti da un commissariato ad un altro (che spesso avvenivano per motivi legati a richieste politiche, o di rimuovere i Serpico o di promuovere i poliziotti “mansueti”); 2) i controlli a campione sulla ricettività dei poliziotti rispetto a “denunce civetta”; 3) controlli affidati ai cittadini sulla ricettività delle denunce; 4) permessi di riposo maggiore per i poliziotti; 5) maggiore training su tecniche investigative o tecniche di comunicazione e servizio ai cittadini.
Quando queste riforme sono state lasciate all’organizzazione interne dei commissariati o dei cittadini (riforme 3 e 4), queste hanno miseramente fallito. Ma altre riforme, obbligatorie o imposte dall’alto, hanno decisamente migliorato la qualità dei servizi di polizia:
a) Il blocco degli spostamento d’ufficio ha ridotto decisamente il “timore della polizia” dichiarato dai cittadini, abituatisi a convivere con lo stesso poliziotto;
b) l’addestramento dei poliziotti, specie quando capillare, ha modificato drasticamente la soddisfazione delle vittime che hanno subito un reato: l’andare dallo zero al 100% nel numero di poliziotti addestrati aumenta la probabilità di soddisfazione delle vittime per l’attenzione ricevuta dalla polizia di quasi 21 punti percentuali (un aumento del 50% della probabilità!).
Così concludono gli autori: “questo saggio dimostra che è possibile influenzare il comportamento e l’immagine pubblica della polizia in un tempo relativamente breve utilizzando riforme semplici e non costose…. Questi risultati suggeriscono che il sistema di polizia, malgrado il suo antico codice, è ben lungi dall’essere resistente al cambiamento e che l’opinione pubblica può essere influenzata nel breve termine e dunque che le riforme con impatto pratico sono possibili in India. Il fatto che siano state realizzate dall’interno delle istituzioni e su larga scala suggeriscono che questi sforzi possono essere aumentati su scala ancora maggiore, replicandoli.”
Ecco, certo che si può fare. Certo che si può.
Se seguiamo chi, volendo arrestare il declino, chiede meno Stato e meno tasse, acceleriamo il nostro declino rispetto ad un mondo dove le tasse dei cittadini sono usate per fare spesa pubblica di buona qualità, come negli altri Paesi di cui inutilmente cerchiamo da mesi di emulare la competitività con altre riforme, inutili o dannose.
Quando vedo sulle pagine dei giornali foto di feste dell’Antica Roma organizzate da pubblici cittadini, ho due tristezze. La prima è perché ho la conferma che persone di quel tipo non potranno mai far partire la rivoluzione della qualità della spesa che questo paese merita e abbisogna. La seconda è che queste persone contribuiscono a far crescere il partito di coloro che credono che lo Stato non sia riformabile e va dismesso e di coloro che, sulla base di ciò, fanno la spending review senza preoccuparsi di distinguere il bambino dall’acqua sporca.
Dobbiamo far crescere il partito di quelli che credono che una terza via sia possibile.
 Trieste, Italia. L’autista alle ore 23 s’infila nel Vecchio Porto. Vuole che io veda. Ora non più zona doganale, o quasi, si può entrare.
Trieste, Italia. L’autista alle ore 23 s’infila nel Vecchio Porto. Vuole che io veda. Ora non più zona doganale, o quasi, si può entrare.