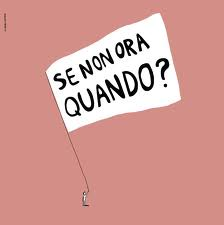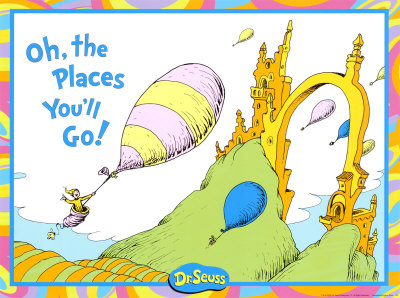Gli articoli di Alberto (Alesina) e Francesco (Giavazzi) sul Corriere della Sera sono sempre un meraviglioso spunto per dibattere la politica economica attuale. Lo sono perché si sforzano di far rientrare dentro un abito di concretezza modelli teorici che non rappresentano la realtà, troppo grassi o troppo magri da poter essere indossati. Come la scarpetta di Cerentola, questa realtà si attaglia a modelli relegati in cantina, a spalare carbone, esclusi dalla festa di palazzo; ma le sorellastre, pur le uniche a discettare davanti al principe-verità, non riescono a calzare l’oggetto, risultando sgraziate e, comunque, rappresentando il modello sbagliato.
Keynes come Cenerentola? Certamente la vita non è fatta solo di momenti straordinari e per fortuna non abbiamo bisogno sempre di Keynes. Ora, oggi, sì. Tutto sta a portare Cenerentola al ballo, via dal suo esilio-prigione, e farla entrare nel castello magico della politica economica, dove l’attende il principe buono che vuole solo il bene dei suoi sudditi e desidera fare la cosa giusta.
Ma voglio tornare su Alesina-Giavazzi (A&G, che sono ben più intelligenti delle brutte sorellastre, quindi il mio paragone fa un po’ acqua). Rileggeteli:
“La correzione dei conti pubblici è costruita prendendo come punto di partenza le previsioni della Commissione. Per l’Italia questa indicano una caduta del reddito di mezzo punto percentuale, cioè un inizio di recessione. E’ proprio questo il motivo per cui il decreto di domenica scorsa si è reso necessario: se le ipotesi fossero rimaste quelle di alcuni mesi fa, prima delle manovre estive del governo di Berlusconi, quando ancora si prevedeva una crescita modesta, ma positiva, questo decreto non sarebbe stato necessario. Alla luce delle nuove previsioni, la Commissione ha calcolato l’entità della manovra per non mancare l’obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013. L’errore è proprio qui, nel ritenere che la crescita dell’economia sia indipendente dalle manovre sui conti pubblici e soprattutto sulla loro composizione (aumenti di tasse o tagli alle spese)”. Se prima di domenica la crescita per il 2012 era prevista a -0,5 per cento, ora sarà necessariamente diversa: … temiamo la caduta del reddito sarà più accentuata … Se ciò si verificasse saremmo da capo: si renderebbe necessaria una nuova manovra. Gli effetti recessivi della manovra potrebbero essere …”.
E dunque: la manovra ha effetti recessivi. Siamo d’accordo. La domanda sorge spontanea. Perché la facciamo? Mica abbiamo eletto politici per fare manovre recessive. Risposta possibile: per fare il bilancio di pareggio nel 2013. Contro risposta: no! Gli stessi A&G ammettono che sin dal Governo Berlusconi questa logica ci allontana sempre più dal raggiungimento non solo dell’obiettivo primario, la crescita, ma anche da quello secondario, il pareggio di bilancio. Un effetto però lo hanno, mano a mano che commettiamo questi errori: diventiamo sempre più poveri! Notate l’errore grave (ingenuo?) del titolo del Corriere: “se la recessione vanifica la manovra” quando è la manovra a vanificare tutto.
E dunque? Lasciamo parlare di nuovo A&G. “Su una cosa concordano tutti gli studi: misure costruite prevalentemente aumentando le tasse sono molto più recessive di quelle costruite riducendo le spese”. Siamo d’accordo. La domanda sorge spontanea. Perché dovremmo aumentare le tasse? E perché dovremmo diminuire la spesa visto che anche questa azione è (meno ma sempre) recessiva? Risposta possibile: per fare il bilancio di pareggio nel 2013? Oh no, già detto, vedi sopra. E allora cosa consigliano A&G? Di non aumentare le tasse e di non ridurre la spesa? No. Di ridurre la spesa e fare le riforme. E perché mai? Perché non fare le riforme, direte voi, e aumentare la spesa (per cose che servono, non per truffe, quella non è spesa, non è domanda pubblica, sono meri trasferimenti dai contribuenti ai corruttori e una riforma intelligente bloccherebbe anche quelli, liberando ulteriori risorse per spendere), visto che le riforme ci mettono anni ad avere effetti (non credo che nemmeno A&G seriamente credano che la riforma delle professioni porti a far crescere il PIL nei prossimi 5 anni) mentre la domanda pubblica tampona nel frattempo la crisi e la disoccupazione che si potrebbero generare? Non è dato sapere.
Come non è dato sapere a che riforme pensano A&G: ma quando parlano di “riforme di cui si parla da anni”, vorrei ricordargli che in quegli anni non vivevamo momenti di così grande disagio e paura. E che alcune riforme, come quelle del mercato del lavoro, durante le recessioni come diceva il Premio Nobel Solow è meglio pensarle bene (“Any gain in labour-market flexibility or in product-market deregulation will be both more effective and more easily accepted if it occurs at a time when aggregate demand is strong and market prospects are favourable”), perché altrimenti rischiano di peggiorare le aspettative, altro che migliorarle.
Quindi bene farà Monti a non ascoltare A&G quando gli dicono che “non c’è tempo per concertare questi provvedimenti con le parti sociali”. Quando non si ascolta e si fanno scelte affrettate, non si aspetta Cenerentola che arrivi al palazzo, si sposa la sorellastra sbagliata e vivremo infelici e scontenti per il resto della nostra vita. E di quella dei nostri figli.