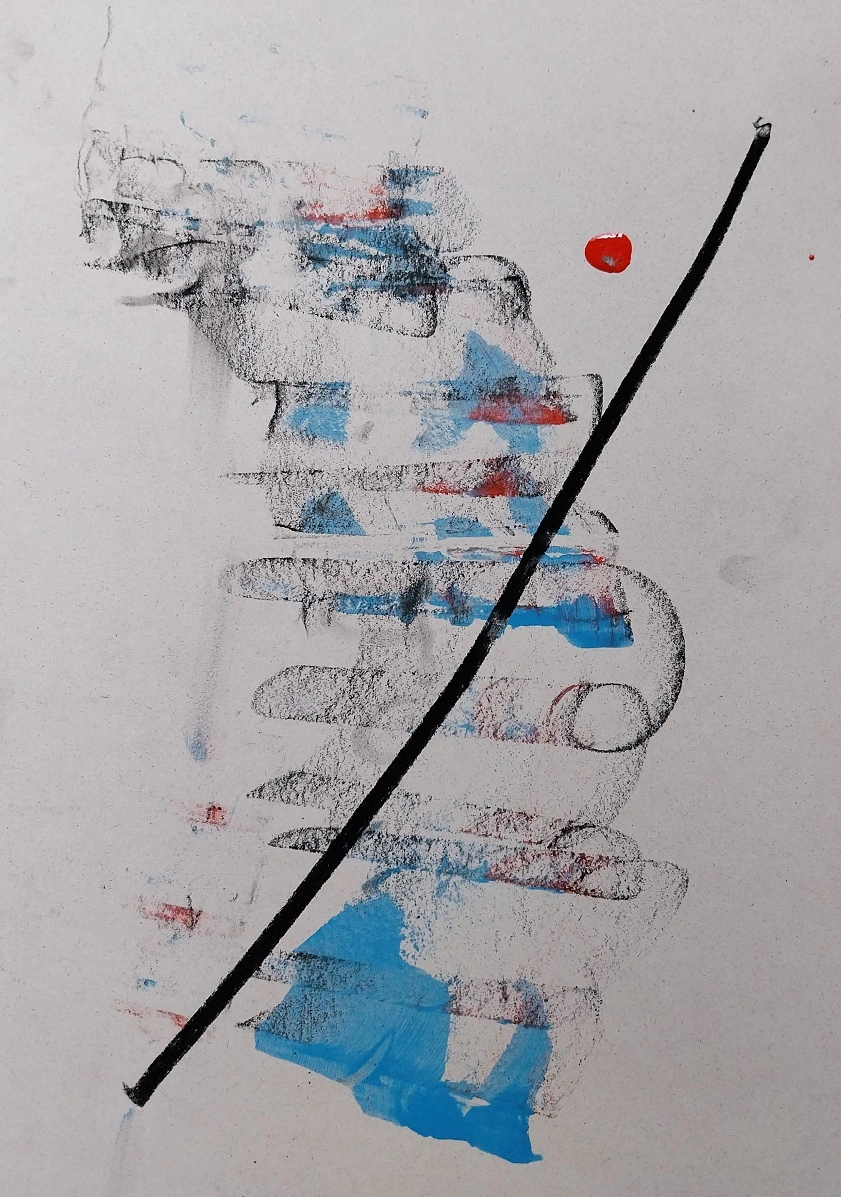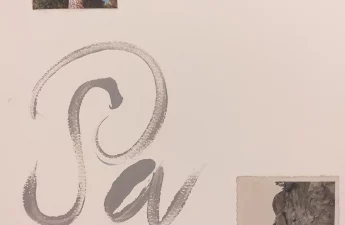Il mio discorso il 6 dicembre in occasione dei vent’anni della Fondazione Promo P.A.
*
Negli ultimi cinquant’anni non abbiamo mai avuto un chiaro senso dei limiti, inferiori o superiori, della spesa pubblica italiana e questo è forse il maggiore difetto che accomuna le nostre politiche fiscali da 50 anni a questa parte.
Ho riletto un intervento sulla spesa pubblica del Professor Sergio Steve, insigne scienziato delle finanze scomparso nel 2006, ad una tavola rotonda dal titolo “una spesa pubblica per lo sviluppo”, all’interno del convegno “Lo Stato e i soldi degli italiani”, svoltosi a Firenze nel 1982 e i cui atti vennero pubblicati dalla Rivista di Politica Economica nel gennaio del 1983. Notate vi prego questa strana coppia: “i soldi degli italiani” che richiama l’esigenza di spendere “poco” (per non tassare troppo) e la “spesa per lo sviluppo” dall’altra parte, che richiama l’esigenza di spendere “ben più di poco”, per la crescita economica e la coesione sociale. Un dilemma sempre presente, quello dello spendere troppo o troppo poco, su cui mi vorrò soffermare, che pare non trovare mai una riconciliazione, necessaria, tra sviluppo e risorse per raggiungerlo.
Sono passati esattamente 40 anni dalla pubblicazione di quell’intervento di Steve e da quel nostro Paese che Steve dipingeva con pennellate sferzanti e preoccupate, fotografandolo con precisione. Rileggendolo, l’ho trovato un’ottima base di partenza per capire cosa sia successo alla spesa pubblica in questi 40 anni, cosa sia rimasto fisso ed immutabile da allora e cosa invece sia cambiato, per il meglio e per il peggio, e cosa possiamo dunque dedurre per il futuro di quella spesa che somma oggi, nella sua interezza, più del 55% del PIL, 10 punti percentuali in più in rapporto al PIL del 1982, l’anno in cui scriveva Steve.
Breve parentesi. Ogni riferimento alla spesa non in valore ma in percentuale del PIL ovviamente dà un’idea, è bene ricordarlo, della pressione fiscale che i cittadini di un Paese devono sostenere nel medio-lungo periodo (astraendo da temporanei deficit che andranno ripagati, con tasse future appunto). Ma non dà un’idea di cosa stia succedendo alla spesa pubblica, ma su questo torno a brevissimo.
Steve avvia la sua riflessione affermando che la situazione era in quel momento storico talmente grave da impedire qualsiasi discussione su di una “spesa pubblica per lo sviluppo” – il titolo della tavola rotonda – e invece obbligava a discutere di come riprendere il controllo della spesa, non tanto riducendola ma almeno riuscendo a fermarne l’apparentemente irresistibile aumento. Ci aveva visto giusto, se 10 anni dopo, nel 1993, questo rapporto avrebbe toccato il suo massimo storico di 56,3%!
Eppure non è corretto, lo sappiamo, da questo rapporto dedurre alcunché sulla dimensione della spesa pubblica in valore: una crescita del rapporto spesa-PIL potrebbe essere assolutamente compatibile con una diminuzione della spesa se il PIL diminuisse ancora di più della spesa. E’ quello che è successo in quest’ultimo drammatico decennio del XXI secolo, in cui, per utilizzare un’espressione à la Steve, bisognava cercare di fermarne l’irresistibile riduzione, di tutte le sue componenti che influenzano il PIL, come investimenti, acquisti, stipendi. Mi piace ricordare come Steve, nella sua analisi, mostrasse la sua estrema preoccupazione per un previsto aumento del personale dipendente del Comune di Roma da 35.000 a 45.000 unità. Oggi siamo a 23.114 o giù di lì, a conferma di quell’afflato austero che ci portiamo appresso da anni, dagli anni della scomparsa di Steve direi.
Steve parlava, a proposito degli eccessi di spesa, di Keynes, ma non come di un tifoso di questi eccessi ma piuttosto come di persona che si sarebbe addirittura spaventata (“con le mani nei capelli”), se in vita, a parlare di più spesa nell’Italia di quegli anni Ottanta. Keynes conosceva bene “i limiti della politica fiscale” scrive Steve. Non potrei essere più d’accordo: sono certo ad esempio che grafici di questo tipo, che mostrano l’inarrestabile crescita dello stato sociale negli Stati Uniti dal dopoguerra – in cui dopo la morte di Keynes il peso della spesa pubblica sul PIL viene a raddoppiarsi in meno di un secolo – lo avrebbero portato ad essere, se risuscitato e oggi tra noi, molto più focalizzato su spending review e abbattimento di sprechi che su deficit come strumento di finanziamento di spese aggiuntive in momenti di difficoltà.
E purtuttavia Steve proseguiva chiedendo di non demonizzare la spesa: se la società italiana ha oggi l’omogeneità e la coesione che ha lo si deve, continuava lo scienziato, in larga misura alla spesa pubblica, con un impatto positivo anche sulla produttività. Siamo nel 1983, anni terribili e di terrore, e facciamo difficoltà a condannare, se adottiamo le lenti di ieri, le spese eccessive di allora per mettere in sicurezza quel Paese con assunzioni che parrebbero scriteriate ai più se avvenissero oggi con quelle modalità di allora.
Steve cerca dunque di trovare una sintesi in questa sua visione ambivalente della spesa pubblica e la trova, questa sintesi, nelle parole “non di un comunista”, “non di un socialdemocratico”, non di un “socialista cristiano”, tifosi dobbiamo presumere, della spesa pubblica senza se e senza ma, ma di Luigi Einaudi. Che, nella sua raccolta, Prediche inutili, scriveva:
“Una società socialmente stabile deve tendere a dare sicurezza di vita alla grandissima maggioranza degli uomini, i quali non mano e non sono in grado di sopportare l’incertezza, non desiderano correre rischi, e non saprebbero affrontarli. E non solo è inevitabile, ma è vantaggioso che i servizi comuni resi dallo Stato diventino sempre più numerosi e vari e ricchi; che l’istruzione gratuita o quasi gratuita dalle prime scuole elementari… giunga fino a quelle superiori e universitarie; che gli enti pubblici forniscano alla collettività servizi, prima ignoti…; che le assicurazioni sociali tolgano agli uomini le preoccupazioni relative ad un minimo di vita normale…. Ad una condizione: che non si raggiunga il punto critico [mio grassetto]. Importa conservare una certa proporzione di cui l’ottima può essere determinata solo da una esperienza sempre rinnovata, fra la quota fissa rigida del prodotto sociale totale e quelle elastica variabile. Alla collettività importa sia serbata in vita, a condizioni di parità con i componenti la maggioranza, la minoranza di uomini disposti a vivere incertamente, a correre rischi, a ricevere onorari invece di salari, profitti invece di interessi. Importa perché non esiste una alternativa: gli uomini della minoranza sono necessari perché il meccanismo economico, sociale, morale, intellettuale di una società viva e progressiva, è necessariamente soggetto a rischi”.
Ora, l’occasione di parlare davanti a Mario Baldassarri, a cui così tanto devo e da cui così tanto ho appreso sul come guardare all’andamento dell’economia ed al suo governo ottimale, l’occasione dicevo mi è utile per ricordare qui un nostro lavoro congiunto del 1995 a cui siamo particolarmente affezionati, dal titolo “equità distributiva ed efficienza economica: trade-off e sinergia”. In quello scritto, credo partendo da una posizione simile a quella di Einaudi, cercavamo di andare un passo più in là, situando il famoso punto critico einaudiano non necessariamente con quello della massima ricchezza oltre alla quale più Stato avrebbe implicato minore crescita, ma piuttosto sostenendo che una società poteva dare valore anche alla maggiore coesione sociale, se così desiderava, anche a costo di qualche decimale di crescita in meno. E tuttavia concludevamo come fosse possibile immaginare un mondo dove, grazie a costanti miglioramenti dinamici nella tecnologia e nella qualità dello Stato, maggiore equità avrebbe potuto nel tempo coesistere con maggiori livelli di crescita, una sorta di ideale modello scandinavo (di allora, forse di non oggi) per la nostra penisola.
Tornando ad Einaudi, Steve lo citava apprezzando il suo appropriato “senso dei limiti” e richiedendo per il Paese un suo ripristino: aveva in mente ovviamente di chiedere di fermare l’eccesso della spesa.
Oggi invece, quel senso dei limiti infranti dall’idiota austerità indotta dal Fiscal Compact europeo da noi firmato ci porterebbe all’opposto, a chiedere più spesa, ma più spesa di qualità.
Steve non era tuttavia concentrato solo su di un modello ideale, “normativo”, della spesa pubblica. Sperava che quel senso dei limiti della spesa potesse essere realizzabile. Ma non ne era poi così convinto: concludeva dicendosi dubbioso “che si possa uscire dalla crisi della spesa pubblica” a causa di nodi politici: “esistono nei nostri meccanismi politici delle spinte che portano all’incremento della spesa, gli interessi della spesa pubblica essendo concentrati e molto sensibili”.
Oggi ci verrebbe da dire che esistono meccanismi politici, forse anche sovranazionali, che portano alla riduzione della spesa pubblica, con interessi per minore spesa altrettanto concentrati e sensibili, prevenendo essenziali investimenti pubblici per la crescita e la messa in sicurezza dei conti pubblici italiani. Eppure è anche vero che gli sprechi abbondano ancora, penso ai 60 miliardi di sprechi nella macchina degli appalti, così ben identificati da 3 ricercatori italiani, la cui eliminazione ci permetterebbe di finanziare spese buone per lo sviluppo senza ricorrere a maggiore tassazione e con minore richiesta di più deficit.
Ci troviamo quindi, oggi come 40 anni fa, nel paradosso di non poter attuare alcun ideale livello combinato di equità e crescita ottimali, per il tramite di una buona spesa, focalizzati come siamo da un lato sull’ansia contabile di misurare quotidianamente il debito e deficit su PIL argomentando che i loro livelli alti richiedono meno Stato e non, come invece dovrebbe essere, più Stato di migliore qualità e, dall’altro lato, nell’incapacità di strutturare percorsi di carriera, qualifiche, competenze, formazione, in grado di permettere alla macchina amministrativa di sostenere più spesa a minor costo (“più TAC spendendo di meno”).
Va dunque trovato, una volta per tutte, un senso dei limiti della spesa: sia rispetto ai suoi eccessi che rispetto ai suoi ridimensionamenti. Va trovato quel punto critico di cui parlava Einaudi, che è funzione a sua volta del tipo di società in cui noi e in special modo le future generazioni vogliamo-vorremo vivere, consci tuttavia che è dall’investimento in capitale umano per le forze della Pubblica Amministrazione che possiamo partire per spostare il punto critico einaudiano sempre più in là. Con questi investimenti in capitale umano della P.A., in formazione e riorganizzazione, a parità di equità e coesione potremo generare più crescita economica, o a parità di crescita potremo garantire più equità. Come? In ambedue i casi finanziando con l’abbattimento degli sprechi che viene dalla competenza gli investimenti pubblici per la crescita, la minore tassazione e/o le spese pubbliche funzionali alla coesione.
La questione si fa urgente e indifferibile perché il futuro richiede una risposta alle ansie, queste sì giustificate, dei giovani che erediteranno un patrimonio, ecologico, infrastrutturale, educativo, sociale, a rischio di sparizione per mancanza di manutenzione e innovazione. I formatori per questa nuova Pubblica Amministrazione ci sono, i 20 anni della Fondazione PromoPa, le migliori pratiche universitarie, specie delle Università pubbliche, sono lì a dimostrarlo. Quindi, al contrario di Steve, voglio chiudere con una nota positiva: è “solo” una questione di leadership, il pesce profuma sempre dalla testa. Ma, sia chiaro, dovrà essere una leadership con spirito di servizio verso il Paese, una leadership con una chiara e largamente condivisa idea di “progetto Paese”, una leadership con una meditata e rappresentativa proposta di punto critico della spesa pubblica.
Grazie ad Annalisa Castelli e Gaetano Scognamiglio.
Opera: “Limiti”. Copyright opere Angela Maria Piga, all rights reserved.