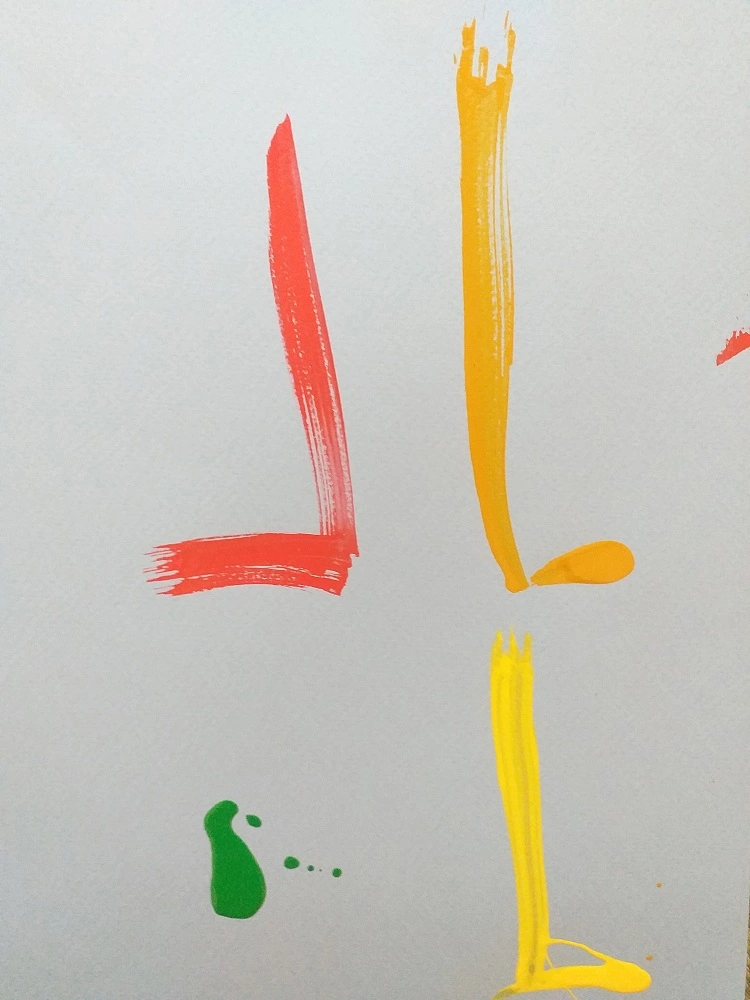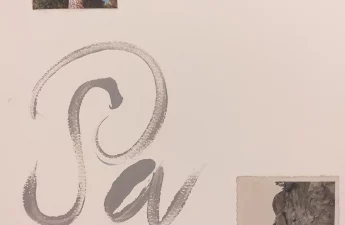Ieri sul Sole 24 Ore.
*
L’unica personalità capace di ingaggiare le istituzioni del Continente a guardare al futuro dell’Unione europea partendo dal dato di fatto della sua incredibile sotto-performance dell’ultimo quindicennio quando paragonata a quella degli Stati Uniti, cercando al contempo di stimolare maggiore consapevolezza nei nostri leader rispetto alle gigantesche sfide che il pianeta si deve porre, pare essere Mario Draghi.
“Il divario è ovunque: nella produttività, nella crescita del Pil, nel Pil pro capite”, ha avuto modo di affermare recentemente l’ex Presidente del Consiglio. Un divario che “si sta allargando soprattutto dopo il 2010”, a causa “di un gap di investimenti pari a 500 miliardi di euro”. I dati in effetti mostrano come questo gap rispetto agli USA, appunto dall’inizio del decennio scorso, si concentri in larga misura negli investimenti pubblici, facendo emergere senza tema di smentite la causa pressoché unica di questa disparità: è infatti dall’inizio della seconda decade del secolo che l’Ue ha deciso, in maniera scriteriata, di allontanarsi dal paradigma di politica fiscale utile a uscire, come ci insegna la storia, da straordinarie crisi finanziarie come quella del 2008.
L’introduzione del Fiscal Compact nel 2011, esperimento unico (sia guardando alla storia passata che a quella corrente di tutte le nazioni del resto del mondo) di politica fiscale, non solo ha impedito fino ai nostri giorni (anche quando il PNRR è diventato operativo!) di usare l’investimento pubblico come leva per sollevarci rapidamente dalla crisi che ci cominciò a attanagliare nel 2009, ma anche di dare occupazione e dignità ai meno abbienti e meno istruiti per il tramite dell’occupazione nei cantieri che si sarebbero aperti, di rilanciare la produttività delle nostre imprese, e infine anche, con la sua prospettiva intertemporale di piani triennali di austerità, di permettere una vigorosa ripresa di pervasivo ottimismo e agli investimenti privati di ripartire, come è avvenuto negli USA.
Le parole di Draghi pongono ora inevitabilmente l’Europa davanti a due questioni di straordinaria importanza: siamo pronti a invertire la marcia con una politica fiscale europea finalmente veramente espansiva? E se sì, come farlo?
La risposta alla prima domanda parrebbe purtroppo un sonoro “no”. In effetti, le recenti reazioni dei governi francesi, tedeschi e italiani di fronte a un peggioramento della loro situazione ciclica, con un PIL minore del previsto per il 2024, è stata emblematica: non tanto quella di voler stabilizzare il PIL al suo livello inizialmente previsto per il tramite di una politica fiscale espansiva, ma piuttosto di stabilizzare il deficit pubblico messo in difficoltà dalla minore crescita, per il tramite di una maggiore austerità (e dunque una successiva ancor minore crescita!). Una reazione che non stupisce chi ha visto nel nuovo accordo sul Patto di Stabilità una tragica conferma dell’ultradecennale austerità, e che rende oggettivamente complesso un cambiamento totale di paradigma come vorrebbe Draghi.
Comunque sia, se anche il Consiglio europeo si convincesse della bontà di una strategia espansiva, bisognerebbe anche chiedersi come finanziare tali massicci investimenti pubblici. Le strade sono ovviamente due: l’una con un debito emesso a livello europeo (e una spesa pubblica inevitabilmente sempre più decisa a Bruxelles), l’altra con un debito emesso in ogni singolo Stato membro (e una spesa pubblica maggiormente decisa a livello nazionale). Draghi predilige la prima soluzione, anche per dare un’accelerazione al progetto prediletto e condivisibile degli Stati Uniti di Europa. Ciò tuttavia presuppone una volontà dei singoli stati membri non solo, come detto prima, di diventare finalmente espansivi, ma anche di rinunciare a un pezzo significativo di sovranità fiscale, operazione che pare particolarmente difficile almeno nei due paesi economicamente più importanti, Francia e Germania, e che potrebbe dare anche adito a una crescita generalizzata dei populismi anti-europei se una politica dall’alto non tenesse conto delle singole esigenze locali per invece prediligere un approccio standardizzato. Dopotutto, il modello sempre citato della centralizzazione statunitense della politica fiscale non si è realizzato che 130 anni dopo l’avvio dell’unione degli stati americani, ossia solo nel momento in cui le specificità e le culture dei singoli stati, finalmente fusesi, lasciarono il passo al New Deal di Roosevelt.
L’alternativa sarebbe quella di chiedere a ogni singolo stato membro di adoperarsi in autonomia, con maggiori deficit nazionali, per finanziare i richiesti investimenti pubblici, per una somma complessivamente identica a quella che Draghi immagina sia da raccogliere in Europa. Il vantaggio di questa mossa, successiva a un accordo comune tra stati membri, sarebbe quella di tenere a bada nazionalismi e populismi anti-europei, un effetto non da poco. Tuttavia richiederebbe, soprattutto all’Italia, di adoperarsi ben più intensamente per apprendere a spendere bene, con una spending review volta anche a mitigare le paure dell’“Europa dei frugali”: opera questa assai complessa, alla luce dei ritardi che abbiamo avuto nel mettere in moto il PNRR e dell’assenza di interesse nell’investire nella qualità del personale della Pubblica Amministrazione. Eppure rimarrebbe una seconda via che potrebbe incamminare il nostro Continente finalmente verso una traiettoria di progresso e crescita, ponendo le basi per una futura unione federale.
Opera: “Pietra d’angolo”. Copyright opere Angela Maria Piga, all rights reserved.