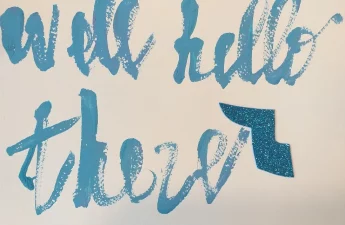Oggi su Il Sole 24 Ore
*
E’ stato Mario Draghi – nel suo intervento di pochi giorni orsono a Cambridge – a riportare il dibattito europeo ad una altezza adeguata al livello delle sfide globali che dobbiamo fronteggiare. Lo ha fatto ponendosi la madre di tutte le domande: dove è appropriato che risiedano i poteri fiscali per fare quanto è necessario per fronteggiare queste sfide, come quelle del cambiamento climatico, dell’energia, di una difesa comune o di una grave crisi economica in uno o più stati membri europei? A Bruxelles, con una politica fiscale integrata, o nelle singole capitali dell’Unione?
E’ una domanda fondamentale per qualsiasi federazione di Paesi: se la posero gli Stati Uniti d’America, dividendosi sin dalla fine del Settecento tra i c.d. “federalisti” – fautori della necessità di uno stato centrale forte – e i c.d. “anti-federalisti” – sostenitori della decentralizzazione, con buona parte dei poteri fiscali da lasciare ai singoli stati dell’Unione. E se oggi parrebbe che l’abbiano spuntata i primi, con Washington luogo simbolo della capacità di spesa pubblica statunitense, è anche vero che fu un esito raggiunto lentamente e non senza ostacoli. Non a caso Draghi ricorda come fu con Roosevelt, negli anni Trenta, e quindi quasi 150 anni dopo l’avvio del progetto federale americano, che il budget USA divenne predominantemente centralizzato. Va inoltre sottolineato come gli anti-federalisti americani non fossero gli equivalenti dei moderni populisti europei, nazionalisti che rifuggono da un progetto comune, ma fossero invece persone seriamente interessate a vedere gli Stati Uniti affermarsi e a non sparire, come temevano sarebbe avvenuto con un progetto centralizzato lontano dai bisogni e ideali dei cittadini degli stati della federazione.
Draghi è facilmente ascrivibile alla categoria dei federalisti europei, forse ne è oggi il più alto rappresentante, ed ha il merito di sollevare una questione dirimente per il futuro dell’Europa. Un federalista che aggiorna la sua visione a seconda dei mutevoli scenari mondiali, come è giusto che sia. Stupiscono quindi fino ad un certo punto due condivisibilissimi nuovi assi del suo ragionamento politico: primo, quello che in Europa “la necessità di maggiore spesa pubblica è incontrovertibile” e che all’interno delle attuali regole si debba trovare spazio per “permettere sufficienti investimenti di lungo periodo”. Secondo, e ancor più innovativo, che la da lui desiderata centralizzazione delle decisioni di spesa e del debito pubblico a Bruxelles non debba avvenire per il tramite di una “integrazione tecnocratica”, cedendo poteri alla Commissione europea, ma attraverso un “genuino processo politico”, mediante referendum nazionali che approvino l’integrazione fiscale. Draghi è ben conscio di come la via referendaria fallì agli inizi del secolo, ma è anche ottimista su come, invece, le odierne condizioni al contorno possano far sperare in un successo. E’, questo, un passo importante anche per un “anti-federalista”, perché rimette al centro le persone e i loro desideri, rispettandone democraticamente la volontà, pre-condizione per l’eventuale successo di qualsiasi riforma della governance fiscale.
Immaginare una nuova stagione referendaria europea non è mossa azzardata. Ma è lecito dubitare, al contrario di quanto non faccia l’ex Premier, che un voto europeo (in ogni Stato membro) abbia esito positivo. E’ dunque doveroso ragionare su un Piano B. Il piano B di un anti-federalista (ma anche di Draghi parrebbe capire) non è quello di prevedere un accentramento tecnocratico nelle mani della Commissione né del sospingere le attuali proposte di regole fiscali comuni, che paiono troppo automatiche, rigide e poco verificabili.
Il Piano B dovrebbe invece considerare le lezioni della Storia, particolarmente di quella statunitense che ci insegna come l’evoluzione verso sistemi federali centralizzati non può che essere lenta e debba tenere conto delle diversità di partenza tra culture locali. Gli Stati Uniti introdussero rigide regole di bilancio in pareggio per i singoli stati dell’Unione solo con il New Deal, quando l’humus culturale era ormai comune, nazionale e non più statale e deficit dal centro in momenti di crisi potevano ben rappresentare, aiutandoli, tutti gli Stati.
Come conciliare dunque l’esigenza di finanziare in deficit spese pubbliche essenziali, come gli investimenti europei per le tematiche di interesse congiunto o le spese per attutire gravi recessioni locali, in assenza e/o in attesa di un bilancio centrale europeo? Draghi ritiene non ideale lasciare autonomia ai singoli Stati membri sul come e quando utilizzare i propri deficit pubblici, lasciando che il rischio di un eventuale fallimento del debito sia condiviso tra mercati e stato sovrano. In realtà è una opzione che negli Stati Uniti dell’Ottocento venne applicata, con il Governo centrale che non intervenne nelle crisi di debito locale né sulle scelte di quanto debito un singolo stato dovesse emettere: troppo giovane e fragile era l’Unione americana di allora per tentare la carta, foriera di controreazioni populiste, della centralizzazione della spesa e del debito, a fronte di un sentimento patriottico comune non ancora cementificatosi propriamente.
Cosa vorrebbe dire questa opzione B per il nostro Paese? Dare all’Italia autonomia di spesa e deficit e confidare nella vigilanza dei mercati potrebbe essere inutile se l’Italia non fosse capace di convincere i mercati della “messa a terra” dei prestiti ricevuti, in progetti che generano crescita e progresso. Ecco perché un do ut des con l’UE che veda il nostro Governo impegnarsi in una seria spending review, a fronte della possibilità di fare investimenti pubblici in deficit, potrebbe essere la migliore alternativa, prima di passare ad una fase referendaria o a valle di un suo, speriamo di no, eventuale insuccesso. Dobbiamo garantire all’Unione europea che sappiamo spendere bene, stabilizzando il rapporto debito-PIL grazie alla crescita dovuta agli investimenti. Il tutto per garantire all’Europa ed al nostro paese di sopravvivere alla malattia del populismo e di inoltrarsi in un futuro di pace e sviluppo sostenibile.
Opera: “Mastermind”. Copyright opere Angela Maria Piga, all rights reserved.