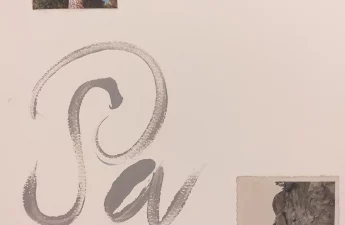Oggi sul Sole 24 Ore.
*
Tra i tanti attori della caduta del governo Draghi, quanta responsabilità si porta dietro l’Unione europea e chi ne ha seguito i suggerimenti? E’ difficile negare di avere assistito in questi ultimi mesi ad un crescendo di dinamiche politiche interne avverse al mix di politica economica e riforme provenienti da Palazzo Chigi, a loro volta sospinte in pieno accordo da Bruxelles. E’ altresì innegabile che il Governo Draghi abbia mostrato, in economia, una sola priorità: quella di rispettare le scadenze drammaticamente serrate (specie per un Paese come il nostro) del PNRR e le condizionalità di questo, che non si limitano a richiederci – pena la sospensione dei pagamenti – di raggiungere “obiettivi” e “traguardi” fissati in sede europea ma anche ad impegnarci in un cammino di rientro del deficit su PIL verso il 3% che ricorda tanto il sado-masochistico Fiscal Compact dell’ultimo decennio.
Il governo Conte “giallorosso” dovette sottostare ad analoghe richieste, visto che l’avvio del PNRR fu da questo generato. E purtuttavia quel governo adottò politiche fiscali – accettate dall’Europa – meno austere di quelle che finì per proporre il governo Draghi. I documenti di economia e finanza e i loro relativi aggiornamenti presentati in Europa confermano ciò: la riduzione del deficit (così austera!) promessa da Conte era pari in 3 anni (dal 2020 al 2023) a 7,8 punti percentuali di PIL. Al suo arrivo Draghi la aumentò, inizialmente in una di 8,4 punti percentuali (dall’11,8% del 2021 al 3,4% del 2024), addirittura poi anticipandone l’avvio durante l’autunno dello stesso 2021, in cui il deficit su PIL venne già ristretto al 9,4%, rinunciando a un prezioso supporto all’economia alle prese con la nuova ondata autunnale di Covid. Che il sentiero stretto del rientro della finanza pubblica sia stato sempre una priorità assoluta per il Governo Draghi (e per l’Europa) lo si è visto quando, in tempi di sopravvenuta guerra e caro-energia, questo ha sempre resistito alle crescenti (e motivate) richieste politiche di uno scostamento di bilancio, dichiarandolo non necessario ed irritando alcuni partiti.
Ma il PNRR non è stato solo questo afflato austero. E’ stato anche una serie impressionante di richieste di riforme. Queste sono piombate sul Paese in una fase di forti difficoltà economiche, mentre è noto come il momento migliore per introdurle, compensando i perdenti, è quello in cui un’economia cresce in termini di risorse generate. Taxi, stabilimenti balneari, termovalorizzatori non sono altro che una lista più simbolica che precisa di questo a volte mal digerito afflato riformista. Eppure il vero problema è stato un altro. Le riforme del PNRR ed i primi investimenti pubblici partiti nel 2021 dovevano anche assicurare benefici al Paese. Così sinora non è stato, e di ciò è bene, verificati i dati, capirne le ragioni.
A guardare i numeri, infatti, l’Italia del PNRR resta il malato d’Europa, indipendentemente, sembra proprio, da chi lo guidi. Numeri alla mano, l’Italia, secondo la Commissione europea, rimarrà a fine 2023 il Paese che avrà recuperato meno di qualsiasi altro il terreno perduto durante Covid: +1.4% contro il 2,8% medio dell’area dell’euro. Dove è l’impatto del PNRR? Lo stesso spread, ben prima delle dimissioni di Draghi era già cresciuto sopra i 200 punti base, all’incirca dove era nell’aprile del 2020, durante il secondo Governo Conte prima dell’avvio del PNRR. Si era poi di fatto dimezzato nella seconda metà del 2020 con l’avvio delle trattative verso la firma del Piano e lì è rimasto un bel po’, anche durante gli inizi del governo Draghi, a conferma delle speranze che il PNRR aveva creato sulla maggiore affidabilità dell’Italia. Il sorprendente riposizionarsi dello spread a dove era prima del PNRR pare una presa d’atto, da parte dei mercati, dell’ineluttabile rischiosità del nostro paese al di là di chi lo governi e al di là addirittura del PNRR con il suo potenziale riformistico di crescita e sviluppo.
Perché la speranza del PNRR pare essere venuta meno? La risposta è che l’Italia di investimenti pubblici dal PNRR ne ha visti sin qui ben pochi rispetto al previsto e per un motivo molto semplice: la lentezza della nostra macchina degli appalti pubblici, che questo Governo (e il precedente) si è colpevolmente rifiutato di modificare rafforzandone la capacità operativa. Una riforma, questa sì essenziale, che è mancata all’appello e che per di più sarebbe stata facile da effettuare perché potenzialmente non invisa da alcun partito. Una riforma che, come in altri paesi europei, richiede di assumere giovani competenti a tempo indeterminato, ben remunerati e dunque sottratti alle lusinghe del settore privato, cui affidare la responsabilità delle gare pubbliche all’interno di 200 stazioni appaltanti diffuse su tutto il territorio. Si è invece clamorosamente preferito di (cercare di) assumere poche persone a tempo determinato a salari poco competitivi, prediligendo poi una riforma (ancora da approvare) degli appalti pubblici il cui punto chiave rimane quello di centralizzare le gare (destinate dunque ad essere di grandi dimensioni) presso poche unità decisionali, escludendo le piccole imprese dalla partecipazione al susseguente sviluppo. Altro che ripresa e resilienza.
Se questo governo Draghi è caduto, faremmo dunque bene ad interrogarci su che ruolo hanno giocato le stupide regole fiscali europee e l’assenza di visione strategica su quello di cui ha bisogno questo paese per ripartire rapidamente, specie in presenza di risorse ingenti da destinare allo sviluppo. Il prossimo Governo e l’Europa con cui questo si confronterà farebbero bene a trarre insegnamenti utili da questa lezione.
“Not I”, copyright opere Angela Maria Piga, all rights reserved.