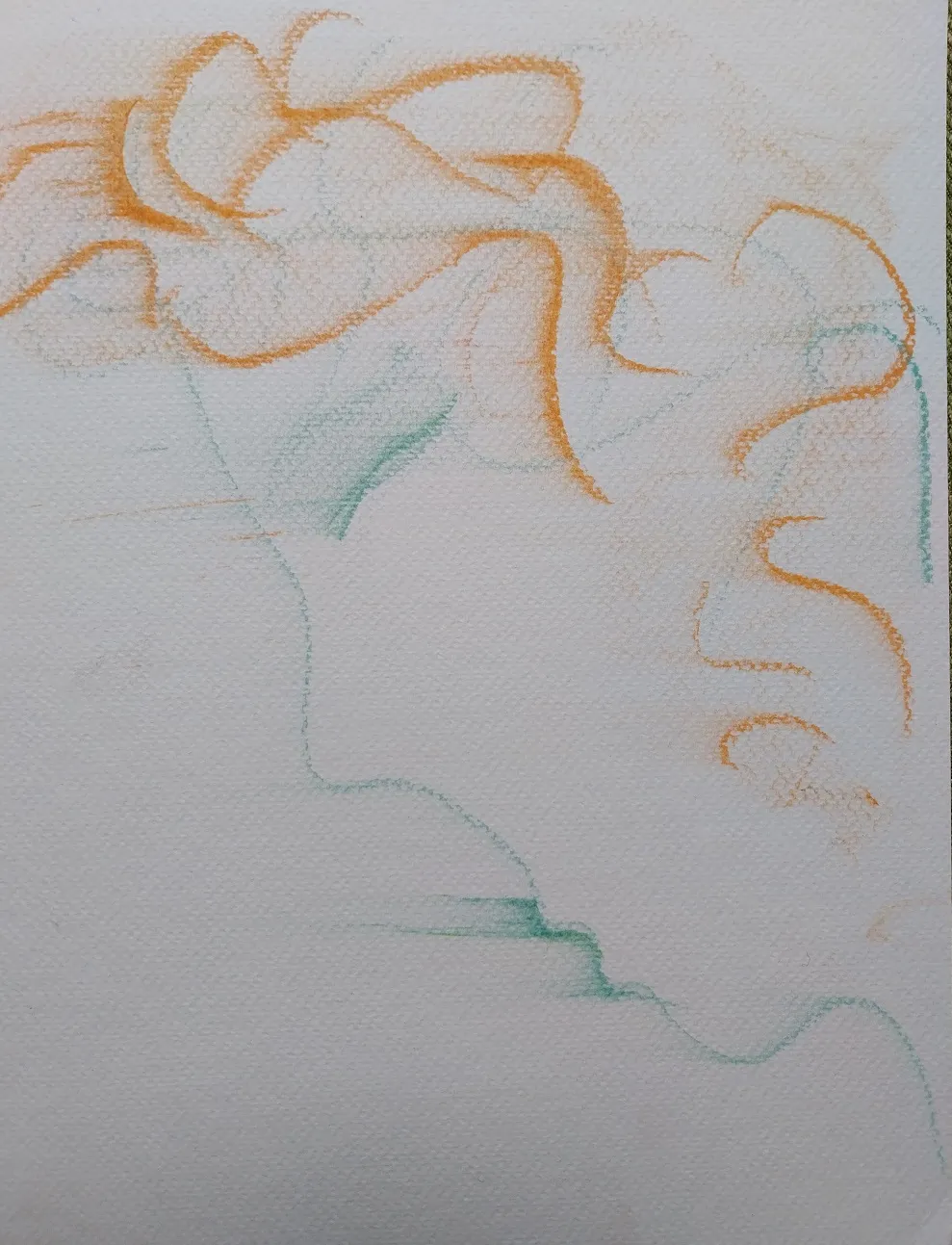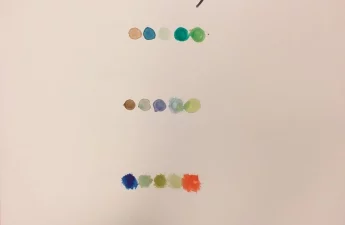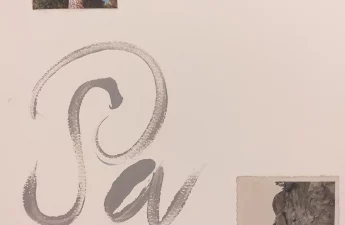Oggi sul Sole 24 ore Annalisa Giachi e Gaetano Scognamiglio
*
E’ in arrivo il 2026, e dunque è tempo di primi bilanci riguardo all’impatto che il PNRR – entrante nel suo ultimo anno di vita – ha avuto sull’economia e la società del nostro Paese. Possiamo apprendere molto dai (pochi) dati a disposizione, quando li leghiamo alle nostre conoscenze teoriche sull’intervento pubblico nell’economia. In primis: è vero che avremmo avuto una minore crescita economica senza il PNRR. Basta fare riferimento agli studi di Banca d’Italia sugli effetti espansivi del moltiplicatore della spesa pubblica in investimenti. Date le ingenti risorse mobilitate dal PNRR e i modesti tassi di crescita ottenuti e attesi tra il 2023 e il 2026, si può dire che il Piano ha evitato la stagnazione (come in Germania) o la recessione. Inoltre, secondo Banca d’Italia, quando un aumento di investimenti pubblici di qualità è finanziato in deficit – come in gran parte per il PNRR – la crescita che ne deriva riduce, e non aumenta, il rapporto debito/PIL. Possiamo dunque anche dire che grazie al PNRR abbiamo evitato che la crescita del debito-PIL, avvenuta tra il 2024 e il 2026, fosse addirittura maggiore.
E’ anche vero tuttavia che, per come è stato ideato dall’Unione europea e per come è stato gestito dall’Italia, il PNRR non ha sviluppato tutto il suo potenziale. I vincoli apposti nel testo approvato a livello europeo (assolutamente negoziabili prima della firma degli Stati membri) hanno infatti danneggiato l’economia italiana. In particolare l’articolo 10 del testo firmato al momento della sottoscrizione del PNRR richiedeva allo Stato membro beneficiario dei fondi di continuare, pena la sospensione del versamento delle rate, nel percorso di riduzione di deficit e di realizzazione di avanzi primari, la c.d. austerità. Così è stato: il valore nominale del surplus previsto dai numeri programmatici cresce da 11,7 mld. di € nel 2024 a 20,35 nel 2025 e ai 27,9 del 2026 (aumento di circa 7,5 mld., effetto netto dell’attuale finanziaria) per finire ai 46,5 nel 2028. Sono tutti aumenti che potevano e possono essere raggiunti in due soli modi, ovvero con aumento delle tasse o diminuzione della spesa, proprio in un momento in cui la nostra economia cresce a stento e avrebbe bisogno dell’opposto. Senza questa clausola dell’art. 10, pretesa dall’Europa, il PNRR avrebbe evitato di suggellare una austerità che gli impedisce oggi di performare quanto avrebbe potuto a favore del PIL e della riduzione del debito-PIL del Paese.
C’è poi un’ulteriore mancata crescita economica: quella derivante dalla spesa in ritardo. I numeri a nostra disposizione ci dicono che dei 194 mld. stanziati, a settembre 2025 85,8 sono stati spesi, avendo dunque ancora da spendere 108,2 mld. Ipotizzando un trend di spesa ottimistico di circa 4 miliardi/mese, si arriverebbe a fine 2026 con circa 146 miliardi di spesa, con un delta quindi di non speso di 48 miliardi. Di questi, circa 20 confluiranno nei nuovi veicoli finanziari attivati con l’ultima revisione del PNRR e potranno essere utilizzati dopo il 2026. Inoltre, la Commissione autorizza l’Italia a usare la quota a debito dei fondi non spesi sulle politiche di coesione. In sintesi, molto sarà stato speso in ritardo, e sappiamo come la puntualità della spesa sia una dimensione decisiva della sua qualità.
Le cause di questa lentezza? In larga parte la mancata o ritardata presenza di investimenti nel capitale umano della Pubblica Amministrazione. Come era infatti possibile immaginare, i tagli alla spesa pubblica e alcune riforme del passato hanno ridotto la capacità programmatoria di soggetti chiave, come le Province, che avrebbero potuto svolgere un ruolo di hub territoriale del procurement ancora più incisivo rispetto a quello comunque garantito durante il PNRR tramite le Stazioni Uniche Appaltanti.
Va riconosciuto che, pur con misure tampone deboli (come le 3.000 assunzioni a termine), la P.A., soprattutto quella locale, ha gestito investimenti almeno tre volte superiori al normale. Questo conferma che, se in passato si fosse investito seriamente in competenze, professionalità e organizzazione – in particolare nelle stazioni appaltanti – l’impatto del PNRR sarebbe stato significativamente maggiore.
Siamo sempre a tempo per provvedere: se così fosse, sarebbe forse il lascito più prezioso del PNRR per le future generazioni.
Opera: “Via col vento”. Copyright opere Angela Maria Piga, all rights reserved.